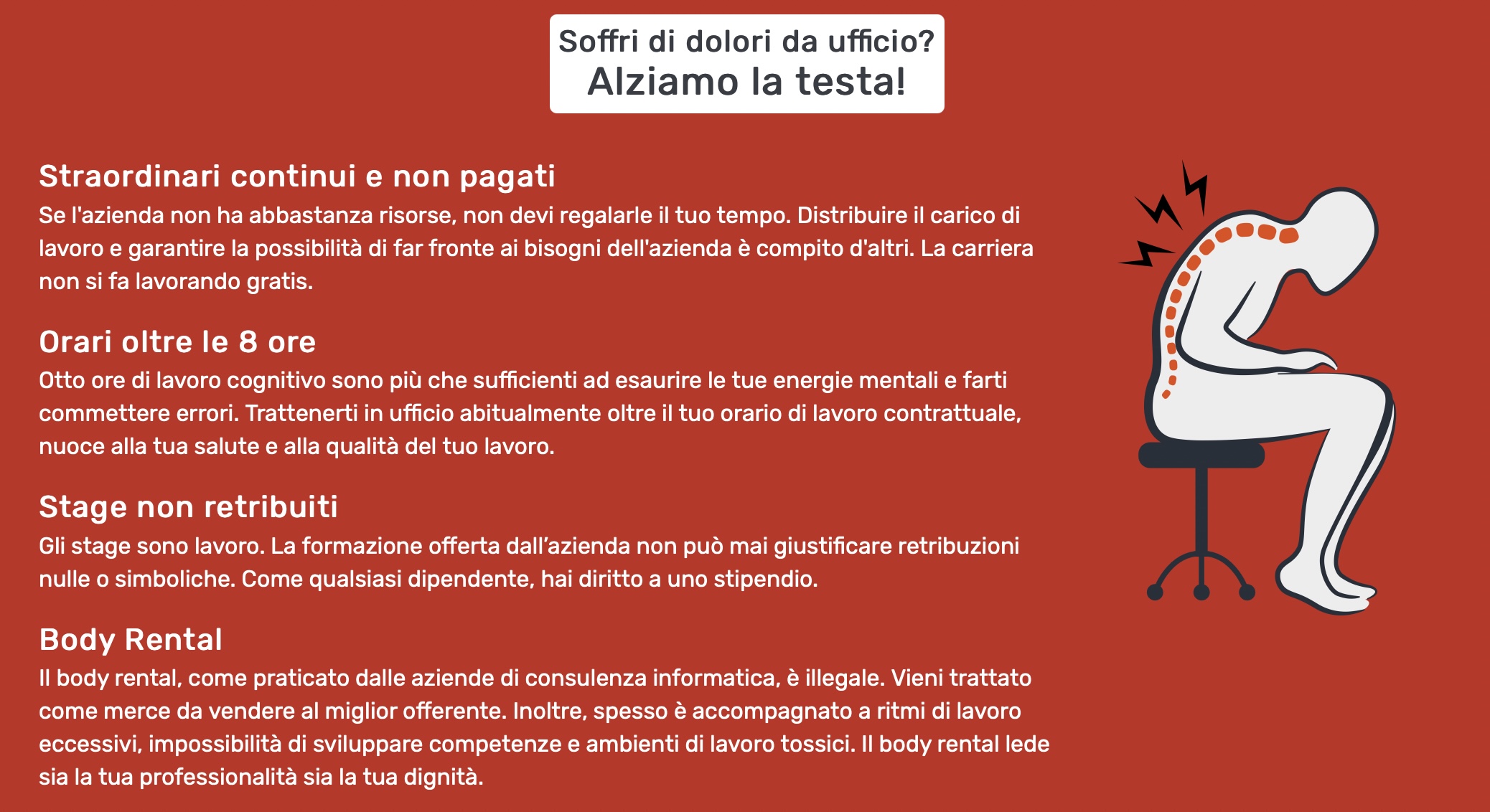Anche nel nostro paese nascono i primi sindacati del settore, ma l’Italia non è la Silicon Valley. “C’è molta poca consapevolezza: c’è la lamentela, ma non si arriva spesso neanche al desiderio di una rivendicazione”
“Le città, il territorio, i rapporti umani e sociali, come abbiamo sentito, stanno per essere investiti da un cambiamento che sarà molto più grande e profondo di quello segnato dall’avvento della televisione. Ma questo cambiamento non è già scritto. Molto dipenderà dal grado di consapevolezza con la quale sapremo affrontare le battaglie decisive di questi prossimi mesi.” L’anno era il 1995 e Sergio Bellucci, allora Responsabile del dipartimento nazionale Comunicazione e Innovazione Tecnologica di Rifondazione Comunista, nato da pochi anni, si preoccupava già da un decennio di ciò che la rivoluzione digitale che stava già travolgendo l’Italia – e il mondo – avrebbe voluto dire per i lavoratori. Già negli anni Ottanta, ha raccontato Bellucci l’anno scorso, da delegato della CGIL presso la Fininvest di Berlusconi aveva cominciato a notare come l’arrivo dei computer stesse sconvolgendo la contrattazione sindacale. Quando l’aveva fatto notare, un compagno del Partito Comunista aveva risposto con un incredulo: “Che cosa stai dicendo? Che dovremo lavorare ai contratti di quelli che lavorano ai computer?” Rispondendo oggi, il sindacalista di lungo corso sa che un contratto collettivo di quelli che lavorano ai computer non basterebbe più: “Non possiamo immaginare di affrontare la trasformazione digitale con la cassetta degli attrezzi del conflitto sul salario o sull’orario — non ci porta più da nessuna parte.”
Lo slancio inaspettato nell’organizzazione collettiva dei lavoratori del settore tecnologico è arrivato oltre un decennio dopo. Nella Silicon Valley si è concentrato soprattutto sul controllo dell’uso finale dei prodotti e sulla lotta contro la discriminazione di genere e razziale sul posto di lavoro. Lo sforzo più recente è l’Alphabet Workers Union, neonato sindacato formato da centinaia di lavoratori di Google, che già negli ultimi anni sono stati in prima fila nel guidare il risveglio dell’attivismo in una Silicon Valley storicamente e culturalmente contraria alla sindacalizzazione.
“Il settore ICT eredita numerose storture che già erano visibili a Berkeley o nei corridoi di IBM negli anni ’60 e ’70, oppure, pochi anni dopo, tra le scrivanie di uno qualsiasi dei nascenti colossi dell’informatica contemporanea,” riassume il programmatore e attivista Simone Robutti in un recente articolo. “Cultura machista e competitiva, dogmatismo tecnico spacciato per razionalità, progressiva depoliticizzazione della produzione digitale in favore di un’ideologia totalizzante che predica l’inevitabilità del cambiamento tecnologico, sempre implicitamente positivo e di cui il programmatore o chi lo paga è artefice, ma non responsabile.”
Non è un caso, allora, che l’aumento della mobilitazione dei tech worker sia andato di pari passo con gli scandali che hanno travolto i giganti del settore, dalla vendita dei prodotti a committenti militari a casi come quello di Cambridge Analytica. “Mi pare degno di nota il fatto che l’apice del trend coincida con il cosiddetto techlash, ovvero l’ondata di scetticismo e critiche nei confronti dei giganti del tech,” osserva Silvio Lorusso, autore di Entreprecariat. “La sindacalizzazione è accompagnata da una più ampia presa di coscienza: sono passati i tempi in cui Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft potevano legittimamente presentarsi come una forza del bene, e non credo che dal disincanto si tornerà indietro.”
O, come scrive Robutti, “Caduta l’illusione che più tecnologia possa essere la risposta, a riempire il vuoto arrivano le più disparate ideologie e soluzioni, alcune latenti da tempo, altre inedite e in piena accelerazione. Progressiste, rivoluzionarie, conservatrici o reazionarie, tutte contribuiscono alla politicizzazione di un settore che fino a poco tempo fa era dominio indiscusso del neoliberalismo, capace di difendere la propria posizione con la giustificazione che la Tecnologia non va politicizzata.”
La lotta a queste storture non si è fermata oltreoceano. Lo possono confermare gli organizzatori di Tech Workers Coalition, gruppo internazionale che punta a organizzare i lavoratori dell’industria tecnologica — dai programmatori ai rider, dai sistemisti al personale delle pulizie nelle aziende tech. Fondato nel 2014 da una sindacalista e lavoratrice della mensa di Google, Rachel Melendes, e dall’ingegnere Matt Schaefer, il gruppo è nato in California, ma conta varie sezioni nazionali anche “nella periferia dell’impero” — inclusa l’Italia. La loro prima campagna, intitolata Alziamo la testa, è stata lanciata il novembre scorso con lo scopo di risvegliare anche qui la consapevolezza rispetto alle storture dell’industria tech.
Non è ben chiaro quanti siano, ad oggi, i tech worker nel nostro Paese — a maggior ragione perché non esiste consenso su chi vada incluso nella definizione: secondo Anitec—Assinform, nel 2017 le imprese del settore IT impiegavano circa 430 mila persone all’anno, ma nel dato sono esclusi servizi di telecomunicazione e commercio all’ingrosso.
Ciò che è chiaro è che dietro alla facciata di un settore idilliaco, in cui è molto più facile trovare lavoro a salari più alti della mediocre media italiana, è cresciuto prosperosamente negli anni un sottobosco di sfruttamento a malapena riconosciuto come tale.
“C’è molta poca consapevolezza: c’è la lamentela, ma non si arriva spesso neanche al desiderio di una rivendicazione. A parte una minoranza di persone già politicizzate, c’è un vago desiderio di un contratto nazionale dedicato — idea che per qualche motivo ha un sacco presa, a prescindere da ciò che significa nella pratica — ma si fermano alla lamentela,” racconta uno degli organizzatori di TWC Italia, che ha chiesto di rimanere anonimo. “In Italia c’è questa dissonanza cognitiva tra il fatto che i lavori svolti da chi sta nella Silicon Valley e chi fa il consulente a Milano sono più o meno gli stessi, ma c’è un’enorme differenza tra i due stili di vita: la spiegano con ‘l’anomalia italiana’ — la classe politica, i dirigenti, il sistema paese che non sa fare tecnologia… Ma non si va oltre a questo.” Insomma, come scrive sempre Robutti in una precisissima analisi della situazione italiana, “qui nella provincia le cose sono un po’ diverse: è diverso il tessuto produttivo, è diversa l’identità, sono diversi il volto e la mano del Capitale, è diversa la storia dei movimenti sindacali, sono diversi i valori.”
Così, fare educazione diventa una delle prime cose da fare — un passo necessario, ma non sufficiente. Tra i cavalli di battaglia c’è la lotta agli abusi che tengono bassi i salari — in primis il body rental, pratica illegale in cui una figura professionale viene assunta da un’azienda che svolge un ruolo di intermediazione, “prestando” il lavoratore a un’azienda committente per dei progetti specifici. La pratica permette alle aziende terze di tagliare i costi di gestione della manodopera ed evitare responsabilità — regalando in cambio ritmi di lavoro insostenibili e serie conseguenze psicofisiche. Altrettanto problematico è il mondo della grande consulenza, in cui i professionisti sono sistematicamente incaricati di fornire uno specifico servizio in autonomia, con know-how e mezzi propri — assorbendo, come fa notare TWC, “competenze, bandi e appalti senza investire nulla sul territorio, soffocando la nascita di un tessuto produttivo sano.”
Questi due sistemi hanno le stesse conseguenze deleterie sui lavoratori, come sottolinea anche Robutti: precarietà, scarse possibilità di aggiornamento, salari più bassi dei colleghi regolarmente assunti, assegnazione di mansioni inferiori all’effettiva qualifica o, al contrario, estrema settorializzazione che rende complicato il passaggio ad altri progetti e tecnologie. La ricetta perfetta per ottenere lavoratori demotivati e pronti all’esaurimento nervoso, oltre agli stipendi tra i più bassi in Europa, che portano moltissime menti brillanti a emigrare.
La specificità della situazione italiana è ben chiara agli organizzatori di TWC. “Le dimensioni delle aziende in cui si lavora negli Stati Uniti e la loro importanza nell’economia globale rispetto alle aziende italiane fanno sì che lì i tech worker abbiano spesso una posizione privilegiata, mentre qui sei considerato un lavoratore come tutti gli altri, anche se hai spesso maggiore disponibilità di lavoro rispetto agli altri,” spiegano. “Certo, i tech worker italiani un po’ ci credono dell’ideologia californiana, ma la maggior parte di loro è cinica in merito.”
Per ora, i simpatizzanti sono principalmente programmatori, sistemisti, grafici i cui contratti sono inquadrati in una moltitudine di contratti diversi, da quello metalmeccanico a quello del commercio. proprio questa dispersione fa sì che si fatichi ad ottenere l’attenzione dei sindacati confederali. “I Metalmeccanici agli occhi non solo del pubblico ma anche del sindacalista tradizionale sono quelli che lavorano sulla linea di montaggio in fabbrica, quindi organizzazioni come la FIOM non si sono mai interessate troppo alla realtà dei tech worker, se non raramente a livello locale”, raccontano gli organizzatori di TWC Italia. “Alcuni sindacati hanno cominciato ad avere coscienza di ciò che avviene nel settore, ma non c’è ancora una forte spinta per sindacalizzare queste aziende, al contrario di campi come i trasporti o la logistica”.
Ad avvicinarsi a loro al momento sono soprattutto persone che vengono stremate dal circuito della consulenza. “Da due o tre anni saltano tra varie aziende, ma tutte dello stesso livello. Magari lavorano normalmente 10 o 11 ore al giorno e non hanno tempo di formarsi, migliorare il curriculum e fare il salto verso una condizione migliore — o forse non sanno che esiste una condizione migliore. In tanti vivono in una bolla in cui sono tutti consulenti, tutti i compagni di università fanno bene o male quella cosa lì, e quindi non si immaginano una vita diversa. Ci sono gli estremi, come qualcuno che ci ha raccontato di aver fatto 90 ore di straordinari in un mese.” L’altra storia molto comune è quella del precario che tira avanti con piccoli lavoretti qui e lì, tirando avanti con gente che paga in ritardo, privo di separazione tra vita lavoro. “Non tutte le partite IVA sono precarie,” riassumono, “ma buona parte sì.”
Le rivendicazioni sono molteplici: “Pretendiamo ambienti di lavoro sicuri e salubri, rispetto dei contratti, lotta alla precarietà, tutela degli studenti dalle attività di recruitment predatorio svolte nelle università, autonomia decisionale dei tecnici e lotta al managerialismo,” recita il sito del gruppo. “Pretendiamo salari al pari degli altri paesi europei, così che trasferirsi all’estero diventi una scelta e non una costrizione.”
Per raggiungere questi risultati, da una parte TWC organizza workshop e contenuti di supporto che avvicinino studenti e lavoratori a temi come la sindacalizzazione e le cooperative, dall’altra indica la via verso alternative professionali più soddisfacenti. Sul breve periodo, l’idea è quella di lanciare una mappatura del settore in collaborazione con sindacati e mondo accademico.
Il tutto in un paese in cui manca quasi del tutto una strategia digitale. “Alle alte sfere non hanno idea di cosa sia la sovranità tecnologica, lo sviluppo software, l’organizzazione che c’è dietro,” affermano gli organizzatori di TWC. “L’Italia è una colonia: arrivano, prendono i programmatori un po’ per sviluppare software qua, un po’ all’estero, e ci vendono software sviluppato da altri — ma non siamo veramente integrati. Siamo più una risorsa da sfruttare piuttosto che una nazione al pari con le altre.” Un attore passivo che contribuisce a formare persone competenti per mercati che non sa però espandere nè sfruttare per quanto riguarda la definizione, lo sviluppo e la diffusione della tecnologia. E finendo per sacrificare la possibilità di sviluppare un tessuto produttivo sano e attento alle specificità locali.
Segui Viola su Twitter