“Il titolo è volutamente semplice e letterale: dice che questo è un libro e che parla di bambini soli. Non ci sono misteri né sottintesi, perché la materia che tratta è troppo delicata: Il libro dei bambini soli è il tentativo di far emergere e riscattare delle creature piccole e vulnerabili che soffrono e chiedono con tutte le loro forze di non soffrire più.”
Dal 27 ottobre nelle librerie per i tipi del Saggiatore, è il primo libro di Enrico Sibilla. 47 anni, vive e lavora a Milano.
“C’è una solitudine per così dire quotidiana: siamo stati tutti dei bambini soli in qualche momento della nostra infanzia. E questa condizione non ha nulla a che fare con l’amore o l’attenzione o la capacità dei nostri genitori: anche le creature amatissime sperimentano istanti di intensa solitudine.”
Abbiamo letto Il libro dei bambini soli e ne abbiamo parlato con l’autore.

Come è iniziato il lavoro a questo progetto?
Sin da subito ho concepito il libro come una raccolta di “episodi”, o scene, in cui ogni episodio racconta la storia di un diverso bambino. Se non li definisco dei racconti in senso stretto è perché tra di essi ci sono molteplici legami, alcuni evidenti altri meno, oltre a continui rimandi sia stilistici che tematici.
Ad esempio, in comune c’è il tema del bambino solo come “punzone”, o punteruolo, che è il concetto sottotestuale su cui ho costruito tutto il libro. Secondo questa visione – la definisco così perché è un’immagine che si è proprio manifestata all’improvviso e involontariamente – il tempo del mondo è come un foglio di quaderno ripiegato infinite volte su se stesso fino a diventare un piccolo quadrato di carta, molto spesso. Quel quadrato viene improvvisamente e violentemente penetrato da un punteruolo, un “punzone di carne” che è appunto il Bambino Solo, un archetipo che è estraneo al tempo e allo spazio. Se riapri il foglio, il tempo ti apparirà come una superficie costellata da innumerevoli piccoli fori. Questi fori sono i bambini soli, cioè noi, ma anche i nostri avi e i nostri discendenti. In quei buchi ci sono le nostre intere esistenze, da raccontare e se possibile redimere. Essendo noi il risultato della stessa unica foratura, sperimentiamo tutti la medesima solitudine.
Ma in quest’origine per così dire “cosmica” della solitudine sta anche la sua risoluzione. I sei episodi del libro hanno sempre sviluppi o esiti che sono pura immaginazione, parossismo fantastico, ritorno al Cosmo. Alla fine di ciascun episodio nessun bambino rimane solo. E laddove la salvezza fisica non è possibile, ad esempio nel caso di “Pittura bianca su carta” o de “Il venditore di palloncini”, interviene l’Universo – o meglio: il Multiverso – a risolvere il dolore, a sciogliere la solitudine.

In quale genere lo inseriresti?
Il libro è naturalmente un’opera di prosa, ma l’ho scritto soccombendo a un’ossessione ritmica che ho avuto in testa fin dal primo istante. C’è una figura percussiva incessante e martellante, come un lunghissimo paradiddle, che tiene incatenate tutte le frasi di tutto il libro, dall’incipit alla chiusa finale. Qualcuno ci ha riconosciuto il ritmo novenario pascoliano, e forse è così, ma il riferimento letterario illustre non è stato intenzionale. Certo è che, anche per le letture che lo hanno ispirato e cioè certa altissima poesia contemporanea italiana, mi piacerebbe che Il libro dei bambini soli fosse visto come il tentativo di cimentarmi con la prosa poetica, con tutti gli intrinseci fallimenti che questa impresa fuori dal tempo comporta.
Spesso in tempi recenti si parla di crisi della narrativa come letteratura, o della narrativa contemporanea. È davvero così?
Non saprei davvero dire se la narrativa contemporanea sia in crisi. È una cosa che si dichiara abbastanza ciclicamente. Possibile, piuttosto, che sia proprio la lingua in sé a vivere un’involuzione, se non addirittura uno spogliamento di senso, ma questo è un discorso diverso, più radicale e probabilmente più disperante. Riguardo alla supposta crisi della narrativa, invece, è anzi vero che quest’anno è stato pubblicato Zero K di Don Delillo, un libro di una profondità raggiunta in passato solo da Kafka e che obbliga a fare i conti con l’inafferabilità potente della lingua e del silenzio, con la totale marginalità della trama, con la pura domanda metafisica. Un libro che, a mio modesto parere, non indaga il mistero della morte o formula un’ipotesi su un futuro possibile, come è stato detto, ma che piuttosto sonda in modo chirurgico ma vibrante la vita e la sua essenza. Che poi è ciò che fa la poesia, a cui sono probabilmente più legato e affine.
Quali sono stati i tuoi modelli di riferimento?
I bambini del libro sono soli ma non sono orfani; hanno infatti molti padri illustri a cui spero di aver sottratto qualcosa. In campo letterario due libri di poesia sono stati per me fondamentali in fase di scrittura, e infatti non casualmente affiorano qua e là nelle pagine: Tersa morte di Mario Benedetti e Millimetri di Milo De Angelis. Due altri genitori, non strettamente testuali, sono l’album di musica ambient The Disintegration Loops di William Basinski, il cui approccio alla distruzione come rivelazione della bellezza è, credo, nell’anima di tutto il libro, e i 7 minuti di The Reflecting Pool, l’opera secondo me più inquietante eppure pacificante del video artist Bill Viola.
Ma chi è Enrico Sibilla?
Un esordiente di 47 anni nato e cresciuto a Milano, ma con un legame familiare davvero radicale con l’appennino marchigiano (Pioraco, il paese di mio nonno in provincia di Macerata, è volutamente citato nel testo). Sono un uomo normale che ha scritto un libro in cui sono percolate le esperienze di una vita intera, soprattutto l’essere padre orgoglioso di due ragazzi, a cui voglio soltanto dire, e poi dire ancora: “Non abbiate paura.”
Quanto c’è di autobiografico nel libro?
Nonostante il mio sforzo di mettere tra me e queste storie una distanza necessaria, ad esempio attraverso la lingua, l’immaginario e il ruolo da osservatore esterno, in questo libro c’è sicuramente molto di autobiografico, non tanto nelle singole situazioni in cui si vengono a trovare i protagonisti, quanto in quella sensazione di spaesamento che essi provano nella loro solitudine. È uno spaesamento che a volte prende la forma di un’incredulità quasi paralizzante e altre diventa una rabbia incontenibile. Nell’infanzia, nell’adolescenza e – perché no? – anche nell’età adulta, mi sono trovato – come tutti – in circostanze che mi inchiodavano a quello spaesamento da solitudine. Ma se da ragazzo e da uomo sono riuscito in qualche modo a sciogliere i nodi che via via mi si presentavano, ero rimasto con un debito di soccorso verso quel bambino che sono stato, e verso il quale provo oggi una tenerezza sconfinata. Il libro è quindi, in qualche modo, un’elaborazione postuma e immaginale di certe minime solitudini che ho provato, e che ricordavo enormi perché in realtà ero io a essere piccolo. Un po’ come accade con certi altissimi scivoli su cui da bambini non abbiamo il coraggio di salire e che da adulti ci arrivano alla spalla.
Progetti futuri?
Un altro libro, probabilmente uno soltanto, con cui provare a superare i limiti di questo esordio, che sono le possibilità non ancora esplorate – e vicinissime all’estinzione, temo – della mia lingua. Sto annotando delle cose, riflettendo su delle possibilità, ma per iniziare davvero a scrivere sono necessarie – almeno per me – due condizioni: una tremenda, incontenibile paura di sbagliare e un’incoscienza infantile, quindi temeraria, che cancelli quella paura. È un momento di sospensione che arriva senza annunciarsi e che dura solo il tempo che vuole concedere. Spero di riconoscerlo.
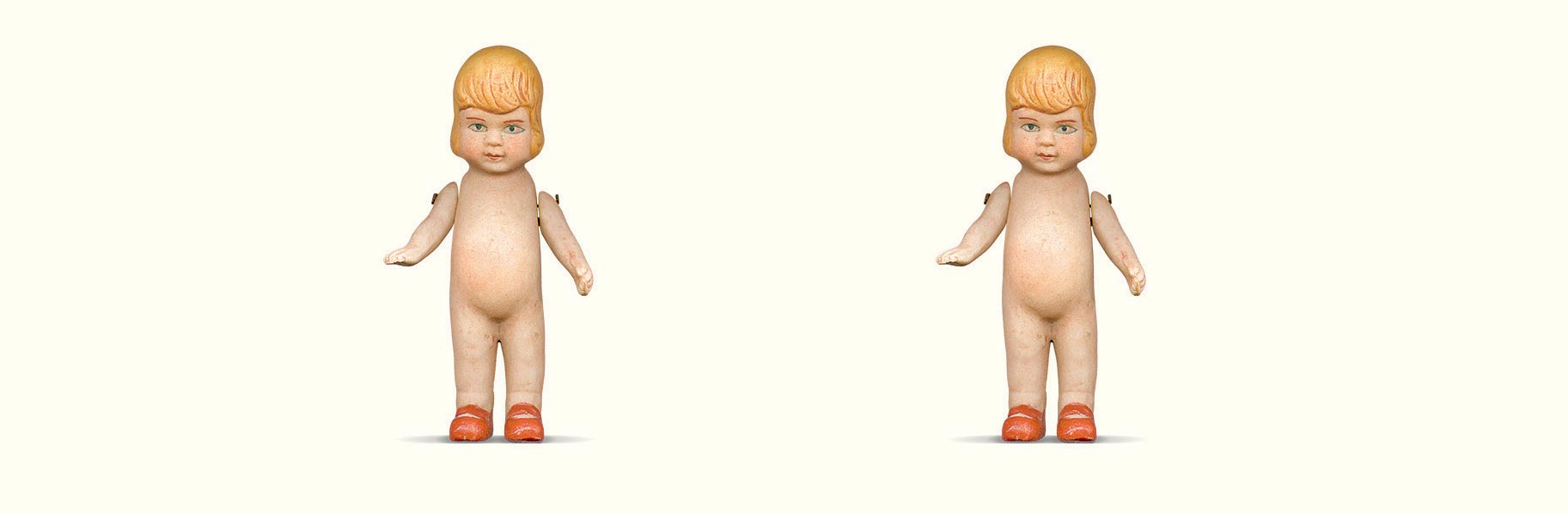
Nel libro di Sibilla, nel linguaggio sonoro, poetico, tra immagini del racconto proustiano e dell’infanzia più fragile, c’è tutta la precarietà di due condizioni – l’età infantile e l’età adulta – che nonostante sempre si sfiorino e si scontrino, mai finiscono per toccarsi davvero.
E in questo scacco – nel fallimento del più intimo primigenio desiderio di raggiungersi, capirsi – ristagnano le sofferenze e le solitudini, ineludibili, cresce il bambino, solo, in angoli angusti limati dal tentativo estremo di avvicinarsi, tra le pieghe del primo rapporto mancato, nell’incomunicabilità atavica di quel dolore.
“Il libro dei bambini soli cerca di individuare e curare proprio quegli istanti, e di salvare i bambini soli che siamo stati. Lo fa in molti modi, che sono poi i modi in cui mi sarebbe piaciuto che salvassero me, le volte in cui mi sono sentito solo.”
Questo l’approdo raggiunto e superato dall’autore, che conclude: non abbiate paura.

