Superati i primi sei mesi del 2017, il verdetto sull’efficacia dei tagli alla produzione di petrolio da parte dei Paesi esportatori sembra impietoso.
L’obiettivo conclamato di questo accordo semestrale era ribilanciare il mercato globale, vessato da una condizione di eccesso di offerta che dura ormai da due anni. Diminuendo la produzione, e di conseguenza le esportazioni, Arabia Saudita e Russia speravano di ridurre il livello delle scorte immagazzinate nei Paesi OECD, appianando la media quinquennale ad un livello accettabile. Per stessa ammissione dell’OPEC però, le inventories sono calate solo leggermente, rimanendo ampiamente sopra la media 2012-2016. Di conseguenza, il prezzo del greggio non ha mai dato veri segnali di ripresa, stabilizzandosi sui 50-55 $ al barile.
Anzi, a marzo, proprio durante il CERAWeek, il mondo è stato scosso da un revival dello shale americano, la quale attività di estrazione è aumentata per 18 settimane di fila, aprendo la strada ad una nuova ondata di greggio non tradizionale. La pressione ribassista si è intensificata, ed il ministro dell’energia saudita Khalid Al-Falih è stato costretto a rispondere in tempo reale del fallimento dell’accordo OPEC-non OPEC. I mesi seguenti sono stati altrettanto tesi, con i Paesi esenti dai tagli come Libia, Nigeria e Iraq che hanno sfruttato l’occasione per impennare le loro esportazioni e i manager degli hedge funds (principalmente americani, ndr) che hanno liquidato una cifra record di contratti futures sul greggio, mai venduti così tanti dal 30 novembre 2016, data in cui furono svelati i tagli di produzione.

In un modo o nell’altro comunque, il 25 maggio, nel quartier generale OPEC a Vienna, è stato raggiunto l’accordo per estendere i tagli per altri 9 mesi. Dopo mesi di retorica, non stupisce se il mercato non abbia reagito subito con un rialzo dei prezzi (in effetti sono scesi di 5 punti appena dopo la firma). Gli operatori avevano già anticipato la notizia, aspettandosela da tempo. Sembra non averlo capito il ministro iraniano Bijan Zanganeh, che si è rivelato “stupito” dal fenomeno. Uno dei pochi a non scomporsi è stata la sua controparte saudita che ha dichiarato di “non prestare attenzione alle fluttuazioni giornaliere”, restando focalizzato sul lungo periodo. Effettivamente, in questi mesi i Paesi OPEC non hanno compreso pienamente il sentimento dei mercati finanziari che, più di tutti gli altri fattori economico-tecnici, conta sui prezzi.
A questo proposito, molti pensano che sia la mancanza di una exit strategy da questi potenziali 15 mesi di stretta produttiva a non convincere gli operatori. Tra questi anche Micheal Cohen di Barclays, che addirittura “non vede la luce in fondo al tunnel”. La mancanza di coesione tra i Paesi esportatori e lo shale boom 2.0, che vede i produttori americani trivellare ancora a piena potenza, sembrano condannare la strategia OPEC. Inoltre, la stabilità portata dall’estensione dell’accordo, potrebbe permettere ai produttori americani di adagiarsi, e continuare a programmare investimenti.
Altri invece, come l’analista John Kemp, si sono resi conto che sono logiche prettamente finanziarie a motivare l’andamento dei prezzi del petrolio. In un illuminante articolo su Reuters, egli spiega che il mercato petrolifero è caratterizzato da due strutture differenti, una alternativa all’altra. La prima è chiamata “contango”, tipica delle situazioni di eccesso di offerta o di un aumento atteso delle scorte (come quella in cui ci troviamo oggi), nella quale i prezzi spot sono più bassi dei loro corrispondenti futures. La seconda è detta “backwardation” e, al contrario, si riscontra quando la domanda è più intensa dell’offerta o quando ci si aspetta che le scorte diminuiscano; questo causa un’inversione della relazione tra spot e futures con i primi che diventano maggiori dei secondi.
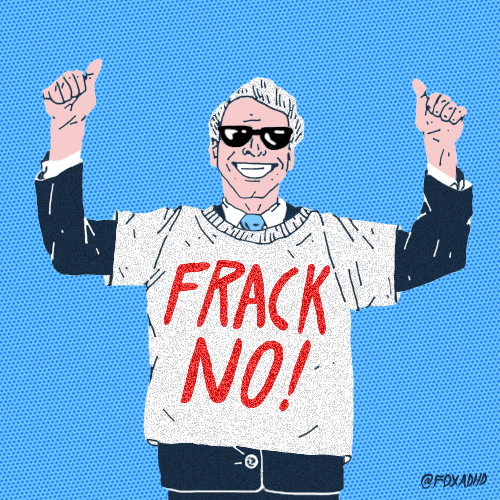
Rimane un’altra premessa da fare, che può avere anche risvolti politici. È noto, infatti, che esiste una differenza tra le strategie delle aziende produttrici americane e arabe. Le prime, che perforano con la tecnica del fracking, più costosa di quella tradizionale, hanno la necessità di compiere operazioni di hedging sulla loro produzione. Ciò significa che proteggono i loro guadagni comprando contratti futures che compensino delle eventuali perdite di profitto legate alle fluttuazioni del prezzo del greggio. Le compagnie medio-orientali invece producono petrolio tradizionale, meno costoso da estrarre e per questo meno rischioso da vendere, per cui non sono solite proteggersi con tecniche di hedging. La conseguenza di ciò è che, mentre il profitto che i Paesi OPEC traggono dal loro petrolio è legato ai prezzi spot (ovvero quelli riscattabili al tempo della chiusura del contratto), il profitto dei produttori americani è legato al prezzo future (ovvero quello riscattato al termine del contratto, tipicamente dopo 1-2 anni dalla chiusura).

Fatte queste dovute premesse, passiamo ai fatti. Dal luglio 2014, il mercato petrolifero è in una situazione di contango, il che ha avvantaggiato gli hedgers, che sono riusciti a realizzare prezzi maggiori dei non hedgers. In altre parole, la struttura del mercato sta avvantaggiando i produttori americani da quasi 3 anni, ed è questo l’ordine che l’OPEC sta cercando di sovvertire. Mentre il suo obiettivo economico è quello di ridurre le scorte presenti nei Paesi OECD, quello finanziario è quello di mandare un segnale al mercato, cercando di passare dal contango alla backwardation.
“Backwardation is the solution” è la sentenza del team di ricerca di Goldman Sachs, espressa in una nota distribuita il 22 maggio.
In quest’ultima, Goldman espone una strategia in tre punti, che permetterebbe all’OPEC di svoltare lo stato attuale delle cose. Per prima cosa, il cartello deve riuscire ad appianare le scorte al livello medio quinquennale. Ed è quello che stanno cercando di fare da novembre. In secondo luogo, una volta completato il primo step, il consiglio della banca d’investimento è quello di riprendere gradualmente i livelli di produzione precedenti ai tagli, ponendo i prezzi futures sotto pressione ribassista. Questo servirebbe a consolidare il passaggio alla backwardation. In ultima istanza, al fine di stabilizzare la nuova struttura, l’OPEC dovrebbe iniziare a stare al passo della domanda globale, aumentando la produzione se necessario.
Per stessa ammissione di Goldman, il piano risulta molto ottimista e di difficile applicazione. Non sempre le strategie finanziarie tengono conto dei fondamentali economici. La diminuzione delle scorte OECD non avrebbe solo una conseguenza finanziaria (la revisione al ribasso dei prezzi futures e il ritorno alla backwardation) ma ne avrebbe anche una economica, e possibilmente, più diretta. Infatti, il ribilanciamento del mercato spingerebbe in alto il livello dei prezzi (non prezzi spot e prezzi futures, che sono aspettative), avvantaggiando sia i produttori sauditi sia quelli americani.
Da questa fitta coltre di calcoli monetari, fa breccia qualche raggio di chiarezza. Il 25 maggio, IHS Markit ha segnalato che, nel 2017, si prevede che i prezzi dei servizi connessi alle attività di fracking aumenteranno. Si tratta di un altro segnale positivo per il settore americano, ormai rinvigorito strutturalmente. Come se non bastasse, la decisione da parte di Arabia Saudita, Egitto, Bahrain, E.A.U, Yemen e Maldive di tagliare ogni rapporto istituzionale con il Qatar, ha fatto schizzare i prezzi dei contratti futures sul greggio. Una reazione simile è naturale, tenendo conto dell’instabilità politica della regione e degli effetti che questa potrebbe avere sulle esportazioni di risorse naturali. Meno ovvio risulta il motivo per cui i Paesi OPEC coinvolti abbiano preso una simile decisione. Più alti sono i futures, più è complicato tornare alla backwardation. Senza backwardation, l’OPEC perde.
Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook

