Perché l’Italia si è dimostrata così impreparata di fronte alla pandemia?
A quasi due mesi dalla diffusione dei contagi nel nostro paese resta ancora senza risposta una domanda fondamentale: perché il nostro paese si è rivelato così impreparato?

in copertina, elaborazione di foto via Facebook
A quasi due mesi dalla diffusione dei contagi nel nostro paese resta ancora senza risposta una domanda fondamentale: perché il nostro paese si è rivelato così impreparato?
Le polemiche dei giorni scorsi sui comportamenti individuali di fronte alle misure di contenimento hanno oscurato, nel dibattito pubblico, un fatto semplice e gravissimo: a tutti i livelli istituzionali sembra che nessuno avesse la minima idea di come affrontare una pandemia come quella di Covid-19. I provvedimenti che si sono accavallati nelle settimane successive all’individuazione dei primi focolai — tra Dpcm, decreti legge, decreti ministeriali, ordinanze regionali e moduli per l’autocertificazione modificati ogni due giorni — sembra siano stati presi “a tentoni,” aggiustando il tiro di volta in volta nella speranza che fossero efficaci. Basta pensare all’iniziale tira e molla tra il governo e le regioni sull’apertura delle scuole, o alla riluttanza nel chiudere almeno una parte delle attività produttive non essenziali (ci è voluto quasi un mese, vari scioperi e un braccio di ferro tra sindacati e Confindustria).
Eppure, c’era l’esempio della Cina a cui guardare per attrezzarsi un minimo ad affrontare la pandemia: le misure di quarantena a Wuhan e nella provincia dello Hubei sono entrate in vigore il 23 gennaio. E il 31 gennaio, dopo la scoperta dei primi casi accertati — i due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani — anche in Italia è stato dichiarato lo stato d’emergenza, per la prima volta in Europa. Come mai, quasi un mese dopo, il contagio ha potuto diffondersi nel Nord del paese in modo praticamente incontrollato, senza che nessuno avesse un piano preciso per contrastarlo?
Quando ormai tutto il paese era già in quarantena e si alzavano in cielo i droni per dare la caccia ai runner, qualcuno ha cominciato a domandarsi perché la possibilità di seguire altri modelli di contenimento del contagio non sia stata nemmeno presa in considerazione. L’esempio più citato riguarda la Corea del Sud, il paese in cui la diffusione del nuovo coronavirus sembra sia stata limitata nella maniera più efficace. L’approccio sudcoreano è stato radicalmente diverso dal nostro: si è concentrato sul tracciamento preciso dei singoli casi, cercando di avere sempre il maggior numero di dati possibili in modo da essere sempre un passo più avanti del virus. Ma in Corea del Sud non sono dei maghi: hanno potuto reagire così perché avevano, appunto, un piano.
Il paese nel 2015 è stato tra i più colpiti dall’epidemia di MERS, una sindrome respiratoria la cui diffusione globale, pur non avendo raggiunto l’Europa, può essere vista come un’anticipazione di quanto sta succedendo con la pandemia di Covid-19. Da quell’esperienza il paese è uscito rafforzato, e quando la nuova epidemia è arrivata non si è fatto trovare del tutto disarmato. Come abbiamo visto anche in Italia, durante l’epidemia di MERS in Corea del Sud 85 dei 186 casi furono causati da trasmissione tra operatori sanitari al Samsung Medical Center. La diffusione non si spiega solo con le condizioni delle camere — molto affollate — degli ospedali sudcoreani, ma anche per la poco puntuale gestione del tracciamento di possibili casi: le autorità avevano ignorato i sintomi di un gruppo di uomini d’affari che venivano dal Bahrain, ignorando le disposizioni dell’OMS perché in quel momento nel paese non erano presenti casi confermati.
La mancanza di rispetto per la privacy delle persone durante la crisi attuale — giustamente criticata quando si parla di “modello sudcoreano” — è stata resa possibile dalla legge sulla prevenzione e il controllo delle malattie infettive, che ha dato massima priorità alla “trasparenza” sui casi di contagio, anche a costo della privacy individuale. Un’ultima differenza fondamentale rispetto alla reazione dei paesi occidentali: la lentezza nell’effettuare e confermare i test era stato un problema rilevante durante la crisi della MERS, e per questo nei mesi successivi è stata approvata in Corea del Sud una legge che permetteva ai laboratori di utilizzare kit di diagnosi ancora non approvati a livello statale in caso di emergenza sanitaria.
Il piano pandemico, questo sconosciuto
Non è necessario, però, essere stati colpiti dalla MERS per elaborare piani un minimo strutturati su cosa fare in caso di pandemia. Il rischio che un fenomeno virale come quello a cui stiamo assistendo potesse causare gravissimi danni alla salute e alla società è infatti noto da tempo, sia come scenario ipotetico — pensiamo a quanti film esistono a tema pandemia, ma anche videogiochi e simulazioni — sia per le altre epidemie virali che negli ultimi due decenni hanno destato una grande preoccupazione nella comunità scientifica e nell’opinione pubblica, dalla SARS all’influenza aviaria.
Proprio per questo, nel lontano 2006 il Ministero della Salute ha stilato un “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale” che — aggiornando quello precedente, del 2002 — seguiva le raccomandazioni dell’OMS che invitavano tutti i paesi a sviluppare un proprio piano pandemico, aggiornandolo periodicamente.
Il piano doveva rappresentare “il riferimento nazionale” in base al quale sarebbero stati messi a punto “i Piani operativi regionali.” A proposito della dinamica tra le istituzioni, nel piano si nota che “una pandemia influenzale costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato: il coordinamento condiviso fra Stato e Regioni e la gestione coordinata costituiscono garanzia di armonizzazione delle misure con quelle che, raccomandate dall’OMS, verranno intraprese da altri Paesi.” Insomma, proprio com’è andata nelle ultime settimane.
Il piano sottolinea l’importanza di conoscere in anticipo le risorse a disposizione per affrontare un’eventuale pandemia, raccomandando di “definire i criteri per la sospensione di ricoveri programmati e la resa in disponibilità di posti letto aggiuntivi” e “individuare le misure di supporto non di tipo sanitario, quali l’incremento dei permessi per assistenza ex-L.104/92, i servizi di assistenza domiciliare (conferimento pasti /spesa), il riconoscimento di permessi lavorativi a volontari.”
Molti dei punti previsti sarebbero tornati estremamente utili oggi, ad esempio per quanto riguarda un’adeguata formazione del personale. Già 13 anni fa si sentiva infatti la necessità di “prevedere tre livelli di realizzazione dell’attività formativa che si [attivassero] a cascata: nazionale/interregionale, regionale, locale.” All’epoca era indicato come “necessario” anche un livello ulteriore di preparazione: “Che a livello regionale [fossero] individuate figure con specifiche competenze didattiche che [potessero] garantire la realizzazione del globale percorso formativo,” con l’obiettivo di “creare una rete di formatori che [assicurasse] la formazione a livello periferico su tutto il territorio” anche grazie a “esercitazioni nazionali e regionali, da concordare fra CCM e Regioni ed altre istituzioni che avrebbero un ruolo in caso di pandemia.”
Ma che cos’è il CCM? La sigla sta per Centro nazionale prevenzione e Controllo Malattie ed è un organo dell’ISS istituito con la legge n° 138 del 26 maggio 2004, il cui scopo originario era “contrastare le emergenze di salute pubblica legate prevalentemente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo,” e che in teoria dovrebbe operare appunto “in coordinamento con le strutture regionali attraverso convenzioni con l’Istituto superiore di sanità,” con attività decise e finanziate su base annuale. Abbiamo chiesto un commento al CCM sull’esistenza e l’implementazione dei piani pandemici, e siamo stati reindirizzati direttamente al ministero della Sanità — da cui non abbiamo ricevuto risposta.
Oggi il CCM esiste ancora, ma sembra essersi distanziato da quella che era una delle sue attività originarie. La pagina “chi siamo” del sito contiene ancora riferimenti allo scopo originario di fondazione del centro, ma sembra che la ragion d’essere dell’istituto si sia progressivamente spostata verso un programma d’azione meno emergenziale. Tra i progetti avviati dal centro negli ultimi cinque anni l’attenzione verso le pandemie come quella che stiamo subendo in queste settimane è sostanzialmente scemata.
Del CCM ha parlato anche Report, in una puntata di andata in onda lunedì 30 marzo. La redazione ha analizzato quello che viene indicato come l’ultimo piano epidemico, aggiornato al 2009, intervistando anche Donato Greco, che per 20 anni è stato a capo del reparto del dipartimenti di epidemiologia dell’ISS. Secondo Greco, la mancanza più grave è soprattutto quella dei piani di contingenza, che secondo l’articolazione del piano principale dovrebbero spettare alle regioni. “Le regioni dovevano aggiungere al piano nazionale i dettagli operativi, addirittura il nome e cognome delle singole persone, il numero di telefono, i depositi, quello che serve per affrontare una pandemia. Lo abbiamo detto chiaro e tondo: mancano i piani di contingenza, quei piani in cui si dice: ‘se si schianta un aereo vicino all’ospedale tu come fai ad avere 300 feriti?’ È quel complesso di operazioni logistiche che permette di affrontare una catastrofe sanitaria in tempi brevi. Servono 50 infermieri in più, dove li prendo?”
Questa mancanza si è fatta sentire con particolare forza in Lombardia. Già tredici anni fa erano specificate alcune indicazioni che, se applicate, avrebbero fatto la differenza nei primi giorni dell’epidemia, a partire dalla necessità di identificare strutture separate in cui trattare i pazienti infetti:
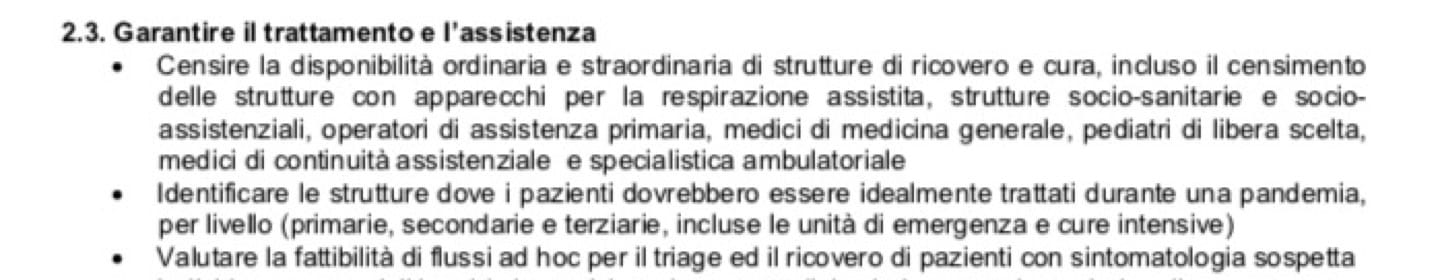
Una necessità avvertita anche da Angelo Giupponi, direttore dell’AREU di Bergamo (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), che il 22 febbraio — subito dopo la scoperta dei primi due focolai nella bassa lodigiana e in provincia di Padova — ha inviato una email all’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia, diretto da Giulio Gallera, facendo notare “l’urgente necessità di allestire degli ospedali esclusivamente riservati a ricoverati per Covid-19, così da evitare promiscuità con altri pazienti e quindi diffusione del virus nelle strutture ospedaliere.” Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, i dirigenti regionali gli avrebbero risposto così: “Non dormiamo da tre giorni, non abbiamo voglia di leggere le tue cazzate.” È logico chiedersi se l’attuale situazione a Bergamo sarebbe stata diversa se la regione avesse preso in considerazione le richieste di chi lavora nel settore anziché farsene beffe. Questa mancanza di organizzazione è confermata anche dalle drammatiche testimonianze che arrivano dagli ospedali lombardi, diventati veri e propri centri di diffusione della pandemia a causa della mancanza di protezioni individuali per il personale sanitario e di percorsi differenziati per i pazienti infetti. Abbiamo chiesto un commento all’ufficio stampa dell’assessore Gallera, che dopo averci promesso di farci parlare con “un esperto” non ha più risposto ai nostri contatti.
Il prezzo altissimo pagato dal personale sanitario è diretta conseguenza di questa impreparazione: a ieri si contano ufficialmente 63 medici morti e più del 9% del totale dei contagiati ufficiali tra gli operatori sanitari — un numero altissimo, e una percentuale circa doppia rispetto a quella registrata in Cina. A loro volta i medici possono diventare in molti casi un veicolo di contagio, rendendo più difficile il contenimento della pandemia. La puntata di Report che abbiamo già citato si sofferma a lungo sulla drammatica carenza di dispositivi medici in tutta Italia. Nonostante ciò, il primo protocollo dedicato alla tutela dei lavoratori del sistema sanitario è stato firmato solo il 25 marzo, a circa un mese dall’inizio della pandemia sul suolo italiano.
Oggi un numero imprecisato di persone muore in casa, o nelle case di riposo, perché non viene accolta in ospedale — secondo le parole del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, sono “lasciati morire.” Molti pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia ad altre regioni, o addirittura in altri stati, perché giorno per giorno ci si è mossi sul filo della capienza massima di posti in terapia intensiva. Eppure il piano del 2006 invitava le amministrazioni ad agire per tempo, e in tempi normali “identificare le strutture dove i pazienti dovrebbero essere idealmente trattati durante una pandemia, per livello (primarie, secondarie e terziarie, incluse le unità di emergenza e cure intensive); valutare la fattibilità di flussi ad hoc per il triage e il ricovero di pazienti con sintomatologia sospetta; individuare potenziali luoghi alternativi per le cure mediche (ad es. scuole, ambulatori).”
Nulla di tutto questo è stato fatto prima, e l’impreparazione generale a trattare un numero di malati superiore al previsto è emerso con evidenza nella tragicomica vicenda dell’ospedale alla Fiera di Milano. Ecco cosa diceva l’assessore regionale al Welfare Gallera riguardo alla difficoltà di trovare i respiratori, lo scorso 17 marzo:
“La Protezione Civile ci ha detto chiaramente ‘noi oggi non siamo in grado di recuperare 500 kit di terapia intensiva e il personale idoneo’. Magari Guido Bertolaso, che ha una fama internazionale e un nome che ha un peso sulla scena mondiale, può avere accesso a rapporti sia con aziende che con governi che ci consentono di ovviare a questi problemi”.
Insomma una linea di totale improvvisazione: magari Guido Bertolaso… Dopo più di dieci giorni, l’ospedale è pronto — oggi è stato inaugurato e ieri è stato benedetto dall’arcivescovo — e dovrebbe accogliere i primi malati alla fine di questa settimana; la capienza, che doveva essere in origine di 5-600 pazienti, è stata progressivamente ridotta a circa 200 posti letto, di cui soli 50 disponibili subito; Bertolaso ha contratto a sua volta il nuovo coronavirus e si trova in isolamento al San Raffaele — da dove però continua a lavorare, reperendo attrezzature “in giro per il mondo.”

La disorganizzazione ha generato quello che può essere definito un vero e proprio panico istituzionale, che si è tradotto in un conflitto tra i vari organi dello stato senza precedenti nella storia della Repubblica. Fin dal primo giorno è risultato evidente che non esisteva un criterio per definire di chi fosse la responsabilità effettiva, e questo si è tradotto in un florilegio di commissari: alla carica di Angelo Borrelli, commissario alla crisi, è stata affiancata quella di Domenico Arcuri, commissario per il potenziamento delle infrastrutture ospedaliere necessarie a far fronte all’emergenza coronavirus — mentre ci sono già un Presidente del consiglio, un ministro della Sanità e decine di governatori e assessori regionali, che in questi giorni sono state tra le figure politicamente più rilevanti e invadenti del dibattito nazionale.
Ma perché, se i piani c’erano, non sono stati applicati? L’abbiamo chiesto al dottor Antonio Pesenti, coordinatore dell’unità di crisi della regione Lombardia per le terapie intensive, che non sembra avere in grande considerazione i piani elaborati secondo le direttive OMS. “È circa 300 anni che non si fa più niente per le epidemie! Penso forse dal Lazzaretto di Milano, del 1600… A parte una cosa ridicola di colera a Napoli…” L’ospedale in Fiera farà capo al Policlinico della città, di cui Pesenti è direttore del reparto anestesia-rianimazione ed emergenza-urgenza. Non sarebbe stato meglio affidarsi a un piano elaborato prima della pandemia per l’ideazione e la costruzione della struttura, anziché essere costretti a provvedere in tutta fretta?
Secondo Pesenti, una parte rilevante dell’impreparazione lombarda e nazionale sarebbe da attribuire alla particolare, inattesa virulenza del virus. “Con H1N1 sono state messe in atto cose preparate prima. Per un’epidemia come la peste però… In quel caso erano adatti alle esigenze.” Ma non si poteva proprio fare niente di più sulla preparazione, visto che esistevano piani come quello del 2006? “Non nego si potesse pensare ad altre cose — ma ci siamo illusi che le malattie infettive semplicemente non esistessero più.” Questo nonostante l’OMS indicasse il possibile insorgere di una pandemia di influenza al terzo posto tra le dieci principali minacce alla salute mondiale nel 2019, e al primo posto dello stesso report per il 2018. Nel 2017 Victoria Y Fan, Dean T Jamison e Lawrence H Summers scrivevano sul Bulletin dell’Organizzazione che “Pochi dubitano che grandi epidemie e pandemie colpiranno ancora, e pochi sosterrebbero che il mondo è adeguatamente preparato.”
Per il capo dell’unità di crisi lombarda avremmo dovuto soprattutto “avere la fortuna che le cose andassero verso uno schema classico, invece sono maturate tutte di botto. Un giorno c’era 1, poi 2 malati, al giorno dopo 50. Non si potevano tracciare contatti, non esiste un paziente zero.” Bisognerà fare qualcosa, quindi, per non farsi trovare impreparati in futuro. “La medicina cambierà, siamo tornati all’epoca delle malattie infettive, come l’ebola. Bisognerà costruire sistemi sanitari adeguati a fenomeni come questo.” Una volta pronto, l’ospedale rientrerà nelle strutture gestite dall’Unità di crisi coordinata da Antonio Pesenti.” Chiediamo quindi al dottore qualche indicazione su come dovranno essere questi nuovi ospedali. “Eh! Sapessi… (ride) Domanda non facile.”
Anche il sistema sanitario lombardo andrà ripensato? “Andrà ripensato, non solo quello lombardo, restituendo alla sanità pubblica un ruolo fondamentale per eliminare le malattie batteriche.” E secondo il dottor Pesenti sembrerebbe che vada ripensata anche la società democratica nel suo insieme: “Oggi l’isolamento sembra un vulnus nello stato di diritto, una volta era obbligatorio, come la galera. Forse abbiamo esagerato con cose come la privacy…”
Al di là dell’erosione dei diritti individuali — un’occorrenza che, come abbiamo visto, è purtroppo molto facile si verifichi in periodi difficili come questo — la pandemia ha svelato per l’ennesima volta molti vizi del problem solving all’italiana: ignorare del tutto il problema fino a che non è troppo tardi, impostare una risposta raffazzonata scaricando sulle persone comuni la responsabilità della gestione della crisi, trovare un colpevole. Per la pandemia, il ruolo di capro espiatorio è toccato agli improbabili runner: chi invece ha ignorato le procedure, definanziato la sanità pubblica e deriso i medici in prima linea, oggi inaugura ospedali.
Segui Stefano su Twitter




