La zarroganza di Guy Ritchie torna al cinema con King Arthur
I film di Guy Ritchie stanno al cinema d’essai come l’hamburger sta all’aragosta, sono un peccato di gola.

Inutile negarlo, i film di Guy Ritchie stanno al cinema d’essai come l’hamburger sta all’aragosta, sono un peccato di gola, che ci si concede in un momento di debolezza e per il quale dopo ci si sente un po’ sporchi dentro, nella coscienza.
Sia chiaro, io #adoro i film di Guy Ritchie. Assaporo con gusto i dialoghi furbescamente sopra le righe, le ambientazioni periferiche e la mescolanza di toni e registri, in poche parole ne apprezzo la zarroganza.
Guy Ritchie – che ha disperatamente cercato di cancellare dalla propria biografia il capitolo “marito di Madonna” – ha costruito la propria carriera su una tipologia di film che hanno come unico obiettivo quello di far divertire il pubblico. E quando parlo di divertimento, non mi riferisco certo ai roboanti e propagandistici film di Michael Bay, ma ad una più attenta costruzione del divertimento — fatta di personaggi, situazioni e dinamiche. Lo dice lo stesso regista parlando di RocknRolla.
“Se vado al cinema e pago quello che c’è da pagare, questo è quello che vorrei vedere per i soldi spesi. Quindi cerco di riflettere su quello a cui sono interessato e spero che l’audience mi segua.”
Come molti registi prima di lui, il lavoro di Guy Ritchie nasce nel mondo della pubblicità e dalle esigenze del pubblico televisivo. Attraverso gli spot della Nike o delle Beats ha imparato a esplorare uno stile accattivante e calamitante, poi riversato nei suoi lungometraggi. Non c’è da sorprendersi quindi se lo spettatore prova una particolare attrazione verso scene come il combattimento di Robert Downey Jr in Sherlock Holmes, sono scene fatte per attrarre lo sguardo e la pancia di chi guarda.
Ed è proprio qui che risiede il tocco di bacchetta magica: le esperienze dei film di Ritchie sono esperienze di pancia, che coinvolgono lo spettatore in azioni aspettate e inaspettate allo stesso tempo. Questa dualità nasce sempre dalle situazioni, spesso inserite in quello che in inglese viene definito l’underworld, il mondo sommerso, spesso criminale e pieno di fascino. “Non so perché, non è una questione intellettuale o viscerale, ma mi piacciono le storie dell’underworld. È efficace ai fini cinematografici perché c’è una linea ben definita tra giusto e sbagliato, quindi è facile inserire il pubblico in questo dilemma e fargli godere un percorso che affrontiamo tutti come individui.”
Zarro e arrogante quindi: pensiamo al Turco e a Franky “Quattro dita” di Snatch, a Harry “l’accetta” di Lock & Stock, a Mr. One Two di RocknRolla, personaggi iperbolici calati in una realtà sporca come quelle delle periferie inglesi.
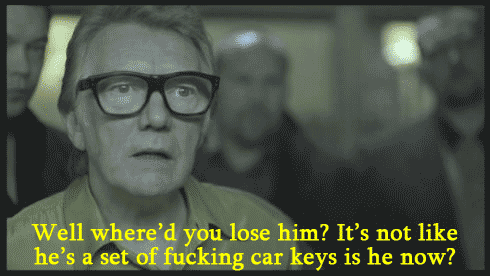
Cosa succede però se questi modelli vengono applicati ai classici della tradizione medievale? Ovviamente King Arthur – Il potere della spada.
La critica statunitense non ha impiegato troppo a bollare il film come cagata pazzesca. Variety ha tranquillamente detto che la Warner Bros ha “spazzato via milioni di dollari per produrre uno sgargiante obbrobrio” (va certo apprezzata l’espressione colorita), mentre l’Hollywood Reporter non si è frenato, affermando che King Arthur è “rumoroso, ampolloso e timbricamente ovvio, un film volgare per tempi volgari.”
Chi scrive – l’avrete capito – non la pensa allo stesso modo. Se a provocare una reazione così sconvolta e scioccata sono gli inseguimenti, le scazzottate e le esplosioni probabilmente andrebbero rivolte le proprie critiche contro altri vitelli dorati (Quali? Gli indizi nell’articolo ci sono già, ma forse serve un aiuto). Se invece a far innervosire i piani alti della critica è la rivisitazione e lo storpiamento di un’opera classica come la leggenda di Re Artù, allora forse bisognerebbe concentrarsi di più su film come Il cacciatore di giganti o il più recente Biancaneve e il Cacciatore — finti baluardi di una finta filosofia liberal, in grado solo di confondere un pubblico già confuso di suo.

Meglio stare in guardia da questo tipo di costruzioni commerciali e godersi di più il peccato di gola, se consapevolmente digerito.




