Giorno 20: Salamanca
Il viaggio sta per finire, il biglietto del treno scade tra pochi giorni, ci sarebbe da spremere ogni ultima possibilità. Ma fa caldo.
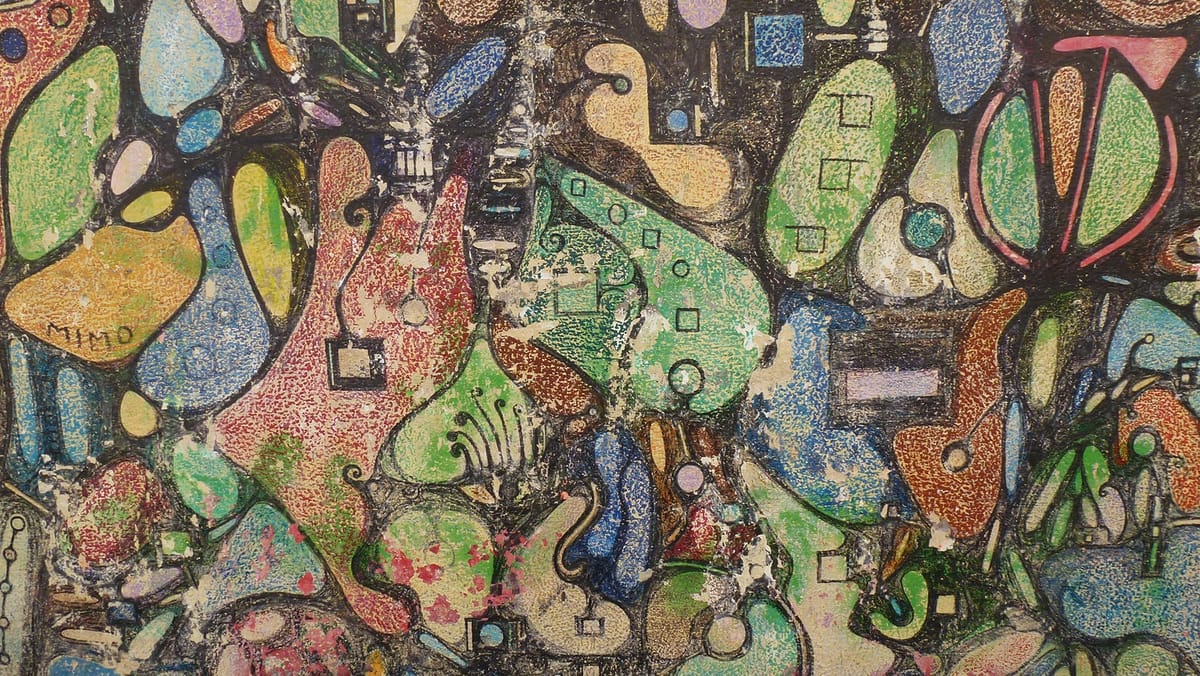
Giorno 20
Salamanca
e treno notturno per Coimbra
Dopo pranzo Salamanca cade in una sonnolenza dorata, sospesa in un alone d’aria estiva bollente e tutto tace. La siesta, suppongo. E mentre arranco per le strade deserte e annaspo nella canicola rischiando, a scelta, insolazione e disidratazione, penso che forse sarebbe il caso di rispettare le tradizioni locali e fermarmi, per un attimo. Oggi il corpo non mi risponde, non mi segue, mi chiede una pausa, o meglio, la impone. Mi accoccolo su una delle poltrone di pelle della sala comune dell’ostello con un cartone di succo di mele sulle ginocchia e mi sento in colpa a stare ferma, a non fare nulla. Tempo sprecato, ci sono cose da vedere, suoni e odori da imprimersi addosso. Il viaggio sta per finire, il biglietto del treno scade tra pochi giorni, ci sarebbe da spremere ogni ultima possibilità. Ma fa caldo.
Non ci provare, mi fanno capire le mie gambe, fermati, chiudi gli occhi, cerca di non muoverti che produci calore umano e la stanza è già incandescente. E poi, detto tra noi, Salamanca è piccolina. Bellissima certo, ma c’è un limite di giri a vuoto che puoi fare nella piazza principale, e le porte delle chiese sembrano tutte chiuse. Sarà la siesta.

I negozi di souvenir sono affollati di centinaia di rane verdi, sulle tazze, nei portachiavi, sulle cartoline e nelle calamite da mettere sul frigorifero. Intuisco che ci deve essere una rana famosa da qualche parte. In uno dei miei slanci di immaginazione poco razionali mi immagino una gigantesca rana in stile pop art che troneggia in qualche piazzetta medievale e decido che il mio obiettivo della giornata è di trovarla, per quanto brutta e inopportuna possa sembrarmi l’idea di una scultura simile in un posto così bello. E poi da qualche parte mi pare d’aver letto che è lunga 180 metri. 180 metri di rana verde non si possono ignorare, e non dovrebbero nemmeno essere così difficili da trovare. 180 metri di rana verde non dovrebbero nemmeno essere plausibili da credere, ma è evidente che la mancanza di sonno mi fa vedere cose che non esistono – per esempio la scritta che pubblicizza i 180 metri di rana che poi non ho mai più trovato, ma per fortuna non la rana in sé, perché se le visioni da stanchezza superano una certa dimensione forse è il caso di farsi ricoverare. Insomma, ovviamente a nessuno è mai venuto in mente di costruire una scultura a forma di rana lunga 180 metri, verde per di più. Lo scopro quando, perplessa dalle mie ricerche andate a vuoto, decido di consultare internet.
La rana, a quanto pare, è in realtà molto piccola ed è raffigurata sopra un teschio sulla facciata storica dell’università. Difficilissima da trovare – altro che i miei 180 metri fosforescenti – si dice che porti fortuna a chi sia in grado di individuarla senza aiuti esterni. Fortuna ovvero
1) sposarsi entro un anno – e va beh che non l’ho vista
2) ritornare a Salamanca – sopravviverò anche senza
3) superare tutti gli esami – ma alla fine mi sono già laureata.
In passato, mi dice Wikipedia, era un simbolo negativo di lussuria, uno dei peccati più facili in cui cadere per gli studenti della prestigiosa università, ed era associata alla morte.
Mi domando, cercando di comunicare con un cameriere, che al mio inglese ha risposto allegramente con un “No te entiendo”, come facciano i turisti che non parlano italiano, o lingue latine in genere, a interagire con la popolazione locale da queste parti. A gesti, suppongo. L’inglese non è contemplato, e capisco molto in fretta che è più conveniente parlare direttamente in italiano e farmi rispondere in spagnolo, evitando sguardi perplessi.

A causa della sosta indesiderata a Irun, e della conseguente tappa non prevista a Salamanca, devo con grande disappunto eliminare Lisbona dall’itinerario di viaggio. Un po’ perché, dovendo essere a Porto entro il 20 luglio, giorno in cui scade il mio biglietto interrail, riuscirei a dedicarle solo qualche ore stordita da un’altra notte passata a (non) dormire su un treno; un po’ perché, davvero, non è il caso che giochi a fare superwoman, ho dato fondo alle mie energie, sono stanca e ad accumulare altre ore di treni e di ritardi di treni non ce la faccio. Opto piuttosto per Coimbra, di cui non so assolutamente nulla, se non che è in Portogallo, che è una cittadina universitaria e che dista solo due ore dalla meta finale. Lisbona sarà per un altro viaggio e un altro momento della vita.
Il treno, quell’unico mitologico treno che ha il privilegio di poter attraversare il confine con il Portogallo – e qualcuno un giorno dovrà spiegarmi perché ce ne è solo uno, di treno, che attraversa il confine con il Portogallo, per di più notturno – parte all’una di notte e arriva alle cinque meno un quarto del mattino, quando, in caso aveste dubbi, fuori è buio pesto e fa un freddo porco.
Poco male, la soddisfazione di riuscire finalmente a varcare le soglie del Portogallo vale la fatica del viaggio, e ormai sono entrata in uno stato soffuso di stordimento per cui, qualunque cosa accada, vado avanti e allo zaino mi sono abituata.
Mentre mi agito sul sedile alla ricerca di una posizione che sia vagamente comoda – gambe sul bracciolo, gambe sullo zaino, gambe incrociate, una gamba piegata sul sedile e l’altra stesa a inceppare il passaggio del controllore, meno male che sono piuttosto snodabile, la mascherina maledizione è sepolta da un groviglio di vestiti nei recessi del bagaglio, okay non dormirò mai – il passeggero dietro di me decide di risolvere lo stesso problema infilando un piede, nudo, nella fessura tra la parete e il mio sedile, per appoggiarlo sul mio bracciolo. Lo guardo orripilata. Va bene il disagio del viaggio, va bene che neanche io sono nella mia forma più smagliante, però il piede così anche no.
Lo fisso per cinque minuti, indecisa su come gestire l’inconveniente. Tento una gomitata sperimentale, ma la posizione deve essere comoda e lo spudorato passeggero russa sonoramente e non da segni di aver sentito. Medito di cambiare posto, ma questo richiederebbe energie vitali che non posseggo al momento. Provo con un’altra gomitata, un po’ più intensa. Niente. La terza gomitata sortisce l’effetto sperato, il passeggero ritira il piede; non è stata una gomitata molto gentile, c’è da dire, ma insomma, avevo anche perso la pazienza.
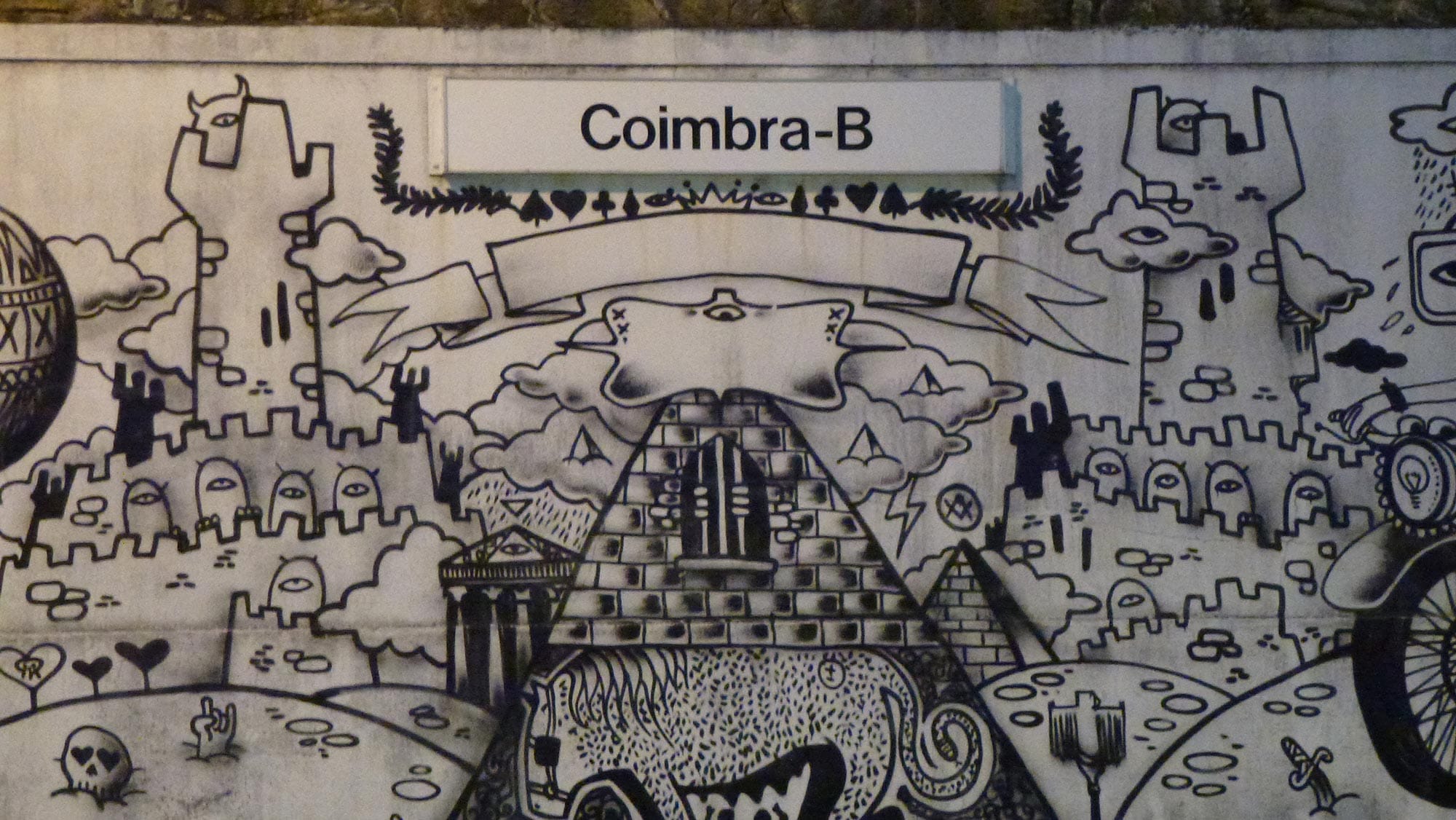
A Coimbra – freddo, buio, umido, tutto chiuso, sì, lo so, l’ho già detto – scendono con me due ragazzine tedesche, diciassettenni, che come me stanno facendo l’interrail e per la prima volta in tutta la vacanza sono io a prendermi cura di qualcuno, e non vice versa. Anche perché la loro disorganizzazione generale è a un livello che io non ho mai raggiunto nemmeno nei miei momenti più gloriosi, e sono ammirata dal fatto che, in qualche modo, a Coimbra ci siano arrivate. Innanzitutto girano con dei trolley di dimensioni mastodontiche, dimensioni da espatrio oltreoceano senza biglietto di ritorno, per essere chiari. Ci potrebbero entrare entrambe, in uno dei loro trolley. Mi spiegano che è perché stanno dormendo nei campeggi, e dentro hanno la tende e tutto il resto, mica vestiti. A occhio e croce di tende lì dentro ne potrebbero avere anche quattro, e comunque la spiegazione non è sufficiente per quanto poco è pratica la loro scelta. Ma si impara dai propri errori, suppongo.
“Tu dove dormi?” mi chiedono, spalancando gli occhi. Quando scoprono che in ostello potrebbero pagare quanto pagano in campeggio, senza l’inconveniente tenda, sembrano deluse. Poi non hanno nemmeno idea di cosa sia l’applicazione per cellulare dell’interrail, che per intenderci è uno degli unici modi per sapere gli orari di tutti i treni europei senza bisogno di internet ed evitare di finire in posti astrusi, senza coincidenze, con un treno al giorno massimo, solo perché sulla cartina sembravano scali ferroviari di grande importanza. Mai fidarsi delle apparenze, e mai fidarsi delle cartine. Mostro loro l’applicazione, e già che ci sono, visto che sono le cinque del mattino e le fanciulle mi sembrano cadute dalle nuvole e devono andare ad Aveiro, controllo che treno devono prendere.
Il treno è già fermo alla banchina, glielo indico. Loro annuiscono, sì, lo sanno che quello è il loro treno. Benissimo. Solo che rimangono lì dove sono fino a circa due minuti dalla partenza, ovvero quando io, preoccupata, faccio loro notare che, nonostante mi faccia molto piacere chiacchierare con loro, il treno lo stanno per perdere. “Ma quello non è il nostro treno!” dice una di loro. Okay, forse c’è stato un problema di incomprensione. “Sì che lo è, va a Porto passando per Averio”. “Ah!” in un improvviso trionfo di gridolini e roteare di braccia afferrano i loro giganteschi bagagli e prendono a correre verso i vagoni, ringraziandomi profusamente. Io scoppio a ridere, ma con gentilezza. “Scaricate l’applicazione!” ricordo loro mentre si arrampicano sul treno e vengono inghiottite dagli scompartimenti. Mi sono state simpatiche. E mi hanno fatto sentire un poco esperta.




