Snapchat, incalzato dalla concorrenza di Instagram, ha annunciato una completa ristrutturazione della sua interfaccia — mentre le Instagram Stories raggiungono i 250 milioni di utenti giornalieri. Ma quali sono i contenuti caricati, possiamo veramente considerarle storie?
Apro Instagram. Avvio con una spolliciata quel carosello di momenti di vita vissuta che sono le stories: gatti, fornelli, libri aperti (sono uno studente quindi seguo amici studenti), fermi immagine dal tram o sulla banchina metropolitana, ancora gatti, video piuttosto random di momenti piuttosto random con scritte piuttosto random, concerti, pubblicità, la vita “imperdibile” di qualche influencer e ancora gatti.
Capite bene che dall’annuncio delle Instagram Stories nell’estate 2016, l’entusiasmo nel seguire le vite degli altri si è spento nel giro di poche settimane, con beneplacito dei miei giga mensili. La delusione però è rimasta: dopotutto Snapchat e Instagram stavano veramente rivoluzionando il linguaggio dei social network, quasi quanto Facebook nel lontano 2004. Allora cosa è andato storto? Perché le storie di Instagram, per non parlare del moribondo Snapchat, si sono trasformate in un aggregatore di noia?
La risposta più immediata è che l’utente medio non sa raccontare una storia.
Per raccontare una storia, ovvero qualcosa di coinvolgente e unitario, bisogna aver prima sviluppato una coscienza comunicativa in grado di distinguere il racconto dalla semplice informazione. Lo sceneggiatore americano David Mamet – famoso per aver raccontato la storia de Gli Intoccabili – ripeteva sempre: “il pubblico non si sintonizzerà mai per vedere delle informazioni, il pubblico si sintonizzerà solo per vedere del drama.” Quando carico la foto di un piatto di sushi sto veicolando un’informazione, se intorno a quella foto invece costruisco un racconto che comprende il dove, il quando, il come e il perché allora sarò sulla strada giusta per raccontare una storia — che sia attraverso selfie o ??.
Purtroppo sembra che le dosi anfetaminiche di serialità assunte grazie a Netflix non abbiano insegnato nulla su come si costruisce un racconto. Risultato: l’instagrammer medio si limita a postare giornalmente tre o quattro storie nell’arco di 24 ore (già con cinque probabilmente rientrate nel decimo percentile). Eppure l’applicazione mette a disposizione tutti gli strumenti necessari per stabilire una continuità narrativa logicamente ed esteticamente comprensibile: audio, video, testo, grafica, emoji — l’ostacolo più grande è appunto la componente umana.
Non fraintendetemi, ormai l’applicazione conta più di 700 milioni di utenti e si calcola che l’introduzione delle storie abbiano aumentato il tempo di frequenza a quasi 30 minuti per utente. Sarebbe sbagliato dire che le persone non sanno usare Instagram, piuttosto facciamo ancora fatica a rapportarci con la sua vera natura.
Nel 1924 un giovane regista russo di nome Dziga Vertov annunciava al mondo il suo manifesto politico, il Kinoglaz (Cineocchio), in cui affermava:
“Io sono il cineocchio. Io sono un occhio meccanico. Io sono una macchina che vi mostrerà il mondo come solo una macchina può fare. D’ora in poi vi libererò dall’umana immobilità. Io sono in perpetuo movimento. Io posso avvicinarmi alle cose e ritirarmi da esse, scivolare sotto di loro, entrarvi dentro. Io posso muovermi sul muso di un cavallo in corsa, fendere le folle e a gran velocità, guidare i soldati in battaglia, decollare come un aeroplano… il cineocchio… include tutti i metodi, senza alcuna eccezione, che permettono di raggiungere e registrare la realtà in movimento.”
Vertov apparteneva alla nuova generazione di cineasti russi nati all’alba della rivoluzione e cresciuti durante gli stravolgimenti politici e culturali del paese, convinti che l’arte dovesse istruire e formare ancor prima di esprimere. La percezione di Vertov dello strumento meccanico è, per certi versi, un’anticipazione del mondo in cui viviamo oggi, dominato dall’immagine e dai processi visuali a cui siamo sottoposti ogni giorno. Non a caso Snapchat (oggi Snap Inc.) non si è mai dichiarato un social network, bensì una “camera company.”
Se in un profano esperimento di sovrapposizioni noi applicassimo le parole di Vertov al brand del fantasmino, le due realtà non suonerebbero poi così distanti.
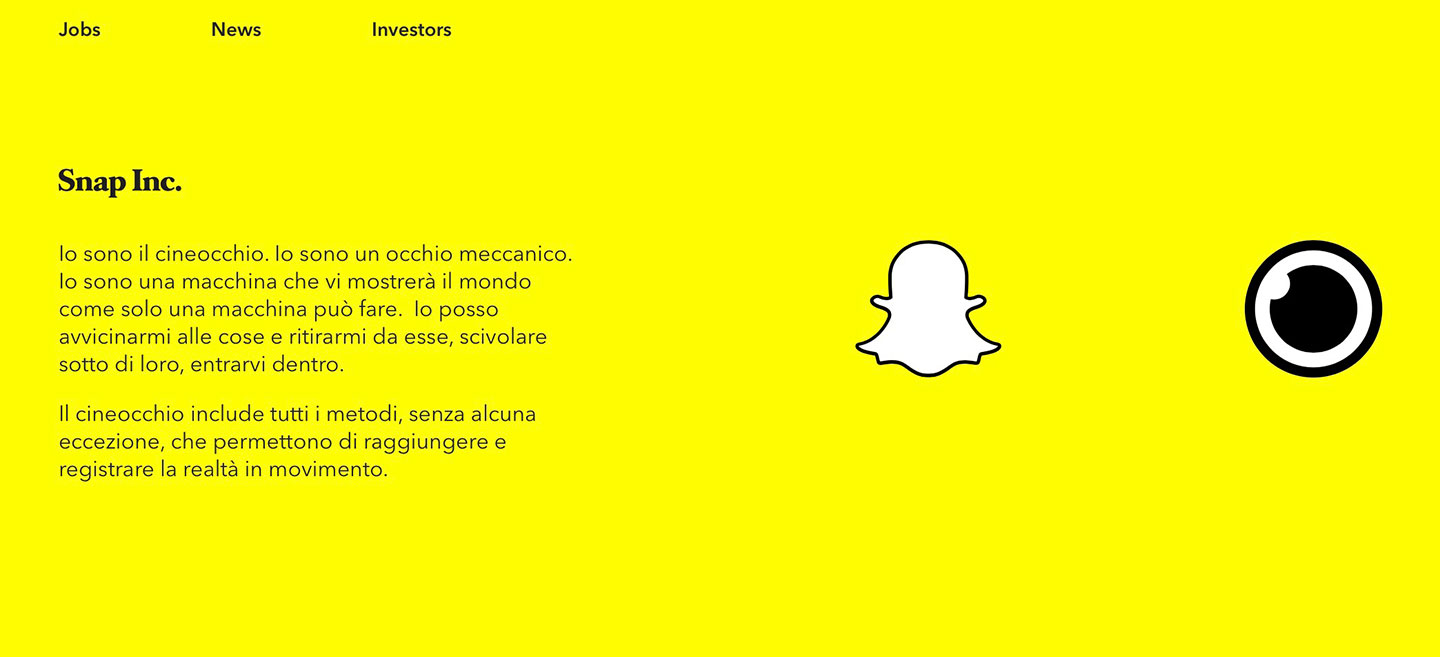
Vertov era l’allievo di un altro grande cineasta della Russia rivoluzionaria: Lev Vladimirovič Kulešov. Ispirato dalle potenzialità del nuovo strumento cinematografico, egli elaborò quello che è passato alla storia come l’effetto Kulešov, un fenomeno cognitivo dimostrato attraverso l’applicazione delle teorie del montaggio.
Se in una sequenza di immagini si accosta il primo piano di un attore privo di emozioni particolari a frammenti di altre pellicole d’archivio, si generano tre diverse combinazioni. Lo spettatore infonderà nel volto dell’attore le sensazioni a cui sono legate le immagini successive — un piatto di minestra sarà la fame, una donna la lussuria, una bara il dolore.
Continuando con la provocazione, l’effetto Kulešov non è altro che una storyben riuscita, in cui il montaggio acquista una funzione semantica oltre che tecnica. Il regista russo dunque propone un’interpretazione del montaggio che dovrebbe risuonare nella mente di chiunque apra Instagram per fare una storia sulla propria giornata.
“L’essenza del cinema sta nella composizione, nella successione dei pezzi girati. Per organizzare l’impressione, conta non tanto ciò che è stato girato in un dato pezzo, ma come un pezzo succede all’altro nel film, come sono costruiti. Il principio organico del cinema non va cercato entro i limiti del pezzo girato, ma nella successione di tali pezzi.”
Per raccontare una storia dunque, la chiave è il montaggio — sarà proprio il montaggio a guidare lo spettatore attraverso la storia e la successione dei suoi pezzi.
A unire i principi studiati da Kulešov e Vertov fu Sergei Eisenstein, che ancora oggi è ricordato come il principale teorico del montaggio cinematografico. Secondo Eisenstein il montaggio non è altro che un’estensione del sensibile, della capacità cioè di rappresentare quello che sperimentiamo con tutte le risorse a disposizione — quindi, come già detto, con immagini, suono, testo e tutto ciò che la tecnologia fornisce.
Il montaggio è quindi immaginazione al lavoro. Se all’inizio si diceva che l’utente medio non sa raccontare una storia, possiamo ora ricondurre la questione a una mancanza di immaginazione: non sa sfruttare le risorse a sua disposizione.
Certo, non dobbiamo dimenticarci che le storie di Snapchat e Instagram sono per loro natura effimere, spariscono nell’arco di 24 ore. Quindi si potrebbe trovare sprecato l’uso della nostra immaginazione per qualcosa che comunque scomparirà in poco tempo. Ma è veramente quello che vogliamo? Vogliamo rifiutarci di dare un valore politico e culturale (così come è stata la rivoluzione dei linguaggi dei cineasti russi) alle nostre storie in nome di una ben più confortevole piega commerciale?
Forse il problema alla base sta proprio in quell’altisonante nomenclatura: Storie. Almeno Snapchat era stata onesta fin dal principio, snap, ovvero foto, ma anche l’aggettivo immediato e improvviso. Qualcosa che quindi non necessita una riflessione, ma che semplicemente cattura un istante. Oggi invece, qualcuno ci ha convinti che ogni giorno stiamo raccontando storie, anche se nella realtà stiamo solo condividendo un collage di momenti sconnessi fra loro.
Proprio in questi giorni Snap Inc. – incalzata dalla competizione di Instagram – ha annunciato un completo ricambio della propria piattaforma per andare incontro alle esigenze degli utenti. Difficilmente questo cambio strutturale cambierà anche l’atteggiamento con cui gli utenti interagiscono e costruiscono i propri contenuti, ma almeno riporterà l’attenzione sui linguaggi che queste applicazioni stanno creando ed evolvendo.
Se volete veramente raccontare delle storie, usate l’immaginazione, fendete le folle a gran velocità, guidate i soldati in battaglia, decollate come aeroplani, ma fatelo ricordandovi che siete voi a usare lo strumento e non viceversa.
Segui Jacopo su Twitter.
Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook

