Nel 1949 la Repubblica Popolare cinese chiudeva i confini alle pellicole prodotte da Hollywood o nella più vicina Hong Kong, trasformando a pieno titolo le sue produzioni cinematografiche nella propaganda del Partito Comunista. Nel 2016 il box office cinese ha registrato un incremento del 50% in più rispetto all’anno precedente, con il record mondiale di 548 milioni di dollari guadagnati in una settimana.
In dieci anni – dal 2005 al 2015 – le sale cinematografiche sono passate da 4 a 31 mila, raggiungendo l’obiettivo di 1,26 miliardi di spettatori in un anno. Per capire come l’industria del cinema cinese si sia trasformata da entità governativa a secondo mercato mondiale bisogna indagare le peculiarità socio-culturali che contraddistinguono il Paese e i piani dei grandi capitali(sti) che stanno dietro alle aziende del settore.
Nel dopoguerra il Partito Comunista trasformò il cinema in uno dei mezzi di propaganda del governo, con la creazione del Shangai Film Studio (ad oggi uno dei tre più grandi studios in Cina), così i vertici si assicurarono una produzione che concentrava la sua attenzione su storie di contadini, soldati e lavoratori. Dalla nascita della Repubblica popolare nel 1949 fino agli anni della Grande rivoluzione culturale l’industria cinematografica produsse oltre 600 film di propaganda e più di 8,000 cinegiornali. Negli anni che seguirono le mobilitazioni studentesche il Partito mantenne una forte influenza sul processo creativo, da una parte inviando giovani registi a studiare il realismo socialista russo e dall’altra costringendo molti artisti impegnati politicamente a trasferirsi all’estero.
La diretta rappresentazione di questo controllo era – ed è tutt’oggi – esplicitata dalle rigide norme della censura, presenza costante in tutti le fasi storiche della cultura cinese. Prima di vederne le caratteristiche, va subito precisato che negli stati occidentali e in Cina le censure hanno funzioni diverse: se nei primi è estesa a una fascia d’età minore per prevenire l’esposizione a contenuti non appropriati come violenza o sesso, in Cina rappresenta il diretto controllo sui contenuti accessibili da adulti e bambini, senza distinzione.
L’organo di controllo è il SARFT (State Administration of Radio Film and Television), una costola del governo che ha diretto controllo su radio, televisione, cinema e internet. Il lavoro del SARFT riguarda la promulgazione e diffusione della moralità confuciana e più in generale della stabilità sociale e politica a partire dalle sceneggiature dei film. I passaggi di valutazione dei materiali sono tre:
- Il Consiglio valuta le sceneggiature sottoposte a giudizio e ha un massimo di 15 giorni per dare l’approvazione.
- Il Consiglio dà quindi suggerimenti su come modificare i contenuti a seconda delle linee guida del Partito, dando la possibilità ai registi di modificare le sceneggiature.
- Infine il regista ha la possibilità di riproporre il materiale rivisto.
Oltre ai più comuni tabù come violenza e sesso, la lista si espande a religione, superstizioni, gioco d’azzardo, alcolismo, uso di droghe e attività criminali. Con l’aggiunta del divieto di affrontare ogni argomento che non sia scientificamente provato, come fantasmi o viaggi nel tempo.

Come fa notare Robert Cain nel suo articolo “Hey, You’ve Got to Hide Your @#!* Away: The Rules of Film Censorship in China” sul blog Chinafilmbiz, “secondo il governo, non accade mai nulla di male nella moderna utopia comunista, se si desidera esplorare eventuali temi salaci, o li si ambienta da qualche altra parte o li si imposta nel passato.” Ecco spiegata l’abbondanza di film sul kung fu e le arti marziali del passato.
Cain continua aggiungendo che “sebbene il sistema possa sembrare draconiano, la realtà è che la censura in Cina è guidata da esseri umani in carne e ossa che spesso vogliono aiutare. I membri del SARFT vogliono sinceramente veder realizzati i film, solo nel 2010 hanno autorizzato la ripresa di più di 500 film.”
È sbagliato e ingenuo pensare che questo sistema influenzi solo le pellicole prodotte in Cina. Come già detto, il mercato cinese è il secondo al mondo per incassi, con la prospettiva di diventare il primo per la fine del 2018 — i produttori esteri (nello specifico Hollywood) si sono quindi trovati costretti negli ultimi anni ad adeguare poco alla volta le produzioni ai modelli cinesi.
“Go to China” dice Jeff Daniels a Gordon-Levitt nel film Looper. “I’m from the future, go to China.”
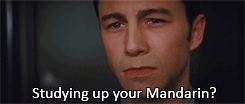
Dopo un accordo economico che gli permetteva l’accesso a fondi statali, il regista di Looper Rian Johnson accettò di trasferire parte della narrazione da Parigi a Shanghai. Il film ha poi casualmente ottenuto più incassi in Cina dalla prima settimana di proiezione rispetto a quella negli Stati Uniti.
Il film di Johnson è stato il primo vero esperimento di collaborazione tra Oriente e Occidente a livello economico — e visti i risultati sempre più registi americani oggi sono disposti a scendere a compromessi per attrarre l’attenzione del pubblico cinese.
Ma la grande muraglia legislativa della Repubblica popolare è ben salda e non fa sconti a nessun ospite.
L’industria cinematografica cinese adotta due sistemi per la distribuzione dei film stranieri sul suo territorio: il revenue sharing, che permette ai distributori esteri di prendere una percentuale sugli incassi, e il flat fee, che invece prevede un pagamento base per i diritti di distribuzione senza guadagni aggiuntivi sui guadagni. A questo va aggiunto il limite di 34 film annui (di cui 14 in 3D o IMAX) con accesso alle sale cinesi.
I film che riescono ad essere ammessi, previa approvazione del Consiglio di censura, hanno un’attrattiva maggiore sul pubblico cinese rispetto alle pellicole native. Nel 2012 gli incassi dei 34 film stranieri hanno rappresentato il 45,6% degli incassi totali al box office cinese. E ad oggi tra i primi 15 film record d’incassi in Cina, ben otto provengono dagli Stati Uniti.
Questo sistema non può che influenzare le produzioni odierne, creando in certi casi estremi senza vie di mezzo. È il caso di The Marmaid e The Great Wall, due film il cui impatto – rispettivamente economico e mediatico – dimostra la difficoltà di approccio all’industria quando si parla di mercato cinese.
Primo film a raggiungere un incasso di 3 miliardi di yen (circa 500 milioni di dollari), The Marmaid è l’esempio più evidente degli effetti del controllo del Partito sul mondo culturale cinese, il successo di una stramba commedia dai toni blandi che nulla aggiunge al clima politico e culturale cinese (ma forse non dovremmo giudicare, visto che in Italia al secondo posto troviamo Checco Zalone).
Se da una parte abbiamo un pubblico che al botteghino dimostra di essere ancora attaccato a prodotti che rispecchiano i tratti della cultura cinese impostata dal governo, dall’altra i grandi capitali attraggono le attenzioni degli investitori statunitensi — prova la produzione di The Great Wall.
Il film è una co-produzione tra Cina e Stati Uniti che aspira ad ottenere un successo direttamente nel mercato orientale. Non a caso il film è stato girato su suolo cinese da Zhang Yimou, noto all’estero per Lanterne Rosse e La Foresta dei Pugnali Volanti. Accusato subito di whitewashing per la presenza di attori americani come Matt Damon e Willem Dafoe, la pellicola rappresenta l’avanguardia in fatto di globalizzazione della settima arte.
“The Great Wall è il primo film con un budget così imponente (160 milioni n.d.r.) che abbia al suo interno una grande forza creativa cinese, questo è l’elemento che viene lasciato fuori dalle critiche” sottolinea Aynne Kokas, autrice del libro Hollywood Made in China.
Sulla carta quindi esiste il giusto equilibrio burocratico ed economico per permettere un’efficace diffusione nel mercato cinese della pellicola. Ma la questione rimane aperta: The Great Wall sarà abbastanza convincente sul piano culturale per smuovere i grandi numeri ottenuti da The Marmaid? Dal successo del film dipende anche il futuro delle nuove fusioni tra aziende cinesi e americane — come quella tra la Wanda Group e la Legendary Enterteinment, casa di produzione di Pacific Rim e Godzilla.
L’impatto dei grandi capitali cinesi è ormai evidente, e anche un mercato relativamente minore come l’Italia ne subisce le conseguenze. Sempre la Wanda Group – fondata dal miliardario Wang Jianlin – questa estate ha acquistato, con un accordo da 500 milioni di sterline, la catena di sale cinematografiche Odeon & Uci Cinemas Group. L’azienda, con sede a Londra, è presente nella penisola con ben 472 schermi.
I cinesi assimilano così le strutture logistiche e i sistemi di produzione, più che i potenziali economici delle aziende acquistate — la capacità quindi di riprodurre i meccanismi che hanno reso grande l’impero di Hollywood.
“Possiamo portare un po’ più di Cina in America e più America in Cina” annuncia Spielberg dopo aver chiuso il contratto con Jack Ma e la sua Alibaba Pictures. L’imprenditore cinese ha aggiunto “non ci sono differenze di valori umani fra Est e Ovest, l’unica differenza è che l’Ovest riesce a raccontare le storie meglio della Cina.” Lo sa bene anche Giuseppe Tornatore, che questa primavera ha firmato un accordo non vincolante per produrre un film in collaborazione con la Alibaba Pictures.
Rimane evidente che la Cina, oltre a incarnare il nuovo pubblico per le grandi produzioni e l’industria mondiale, è anche la nuova frontiera per quanto riguarda gusti e ibridazioni culturali. La speranza è sempre una, quando in gioco ci sono enormi quantità di soldi: che questa iniezione di nuovi capitali in Occidente e l’apertura a nuove prospettive in Oriente diano la possibilità a giovani artisti di cimentarsi nel mestiere del cinema.

