PFAS: l’acqua contaminata scorre nei nostri fiumi, non solo in Veneto
Una falda acquifera inquinata dalle sostanze chimiche invisibili grande come il lago di Garda, 350 mila persone colpite. Il disastro ambientale dei Pfas in Veneto ha prodotto conseguenze invisibili, nella psiche degli abitanti: ne abbiamo parlato con due ricercatori che hanno studiato la psicologia
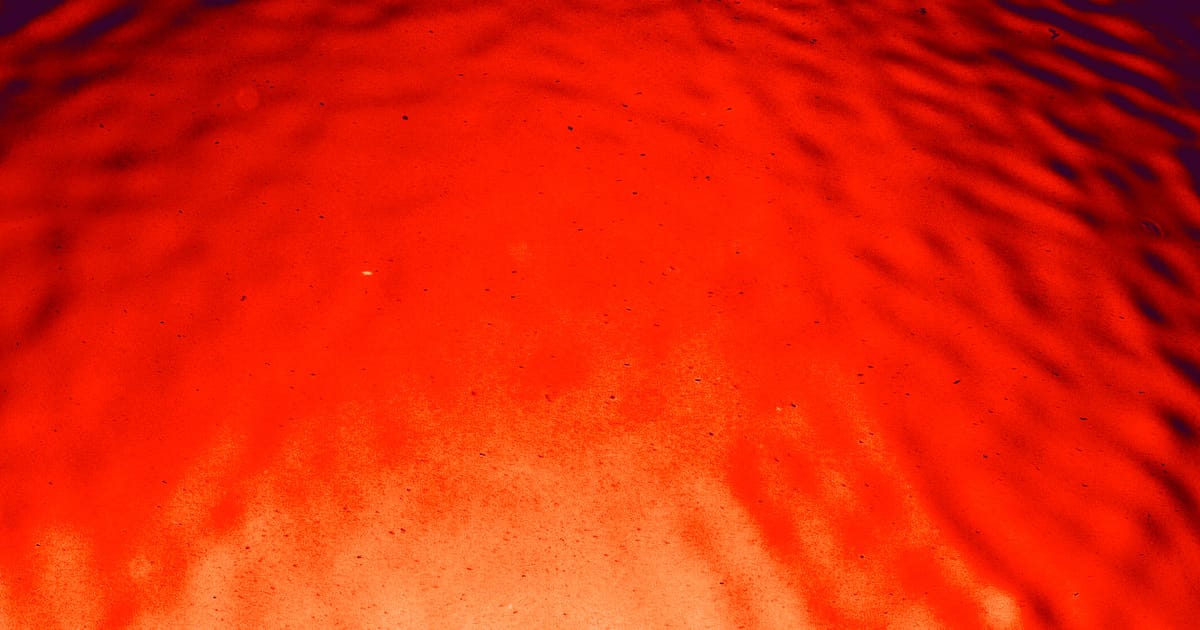
Una falda acquifera inquinata dalle sostanze chimiche invisibili grande come il lago di Garda, 350 mila persone colpite. Il disastro ambientale dei Pfas in Veneto ha prodotto conseguenze invisibili, nella psiche degli abitanti: ne abbiamo parlato con due ricercatori che hanno studiato la psicologia sociale del disastro ecologico dell’ex Miteni a Trissino
I PFAS — o “sostanze perfluoro alchiliche” — sono un gruppo di sostanze inquinanti su cui si sta concentrando negli ultimi anni un’attenzione sempre maggiore, dopo il caso di contaminazione Dupont in Virginia, negli Stati Uniti. I PFAS hanno effetti dannosi soprattutto sul sistema endocrino e sulla fertilità, oltre a essere comprovate sostanze cancerogene. È notizia di questa settimana la conferma della loro presenza praticamente ovunque nei fiumi lombardi, con la presenza più rilevante nelle acque di Olona e Adda.
Secondo l’agenzia statunitense EPA, che si occupa di protezione dell’ambiente, i PFAS consistono in circa 8163 diverse sostanze persistenti nell’ambiente. Sono tutte sostanze chimiche di sintesi, prodotte a partire dagli anni Quaranta e usate, tra gli altri scopi, come rivestimento di contenitori di alimenti, nell’antiaderente delle pentole (teflon), ma anche nei tessuti che rendevano resistenti all’acqua e alla materia grassa.
In Italia la contaminazione più nota e grave è quella della provincia di Vicenza, dove queste sostanze sono state trovate in concentrazioni altissime su un bacino idrico molto ampio. Responsabile della contaminazione è la ex Miteni di Trissino, che per decenni ha sversato queste sostanze nelle falde della zona, causando una calamità ecologica che ora è molto difficile risolvere. La società produttrice di prodotti chimici e farmaceutici è fallita nel 2018.
Il libro Cattive acque, edito da Padova University Press, di Adriano Zamperini e Marialuisa Menegatto, indaga le conseguenze psicosociali di questo disastro ecologico. Per tre anni i due ricercatori hanno fatto domande a donne e uomini che vivono nella zona rossa della contaminazione.
Ciao Adriano, ciao Marialuisa. Perché Cattive acque?
A.Z: Il titolo, Cattive acque, è un omaggio all’omonimo film, su quella class action collettiva negli Usa per la vicenda Dupont, un caso di contaminazione da PFAS in Virginia. L’idea del titolo nasce dall’assonanza semantica: l’acqua è cattiva perché dà l’idea che è marcia, imbevibile, fa male, ma cattiva dà anche un senso di intenzionalità. E in effetti quest’acqua non solo si è limitata a fare qualche cosa ma continuerà nel tempo a fare del male.
Quando avete iniziato a studiare la contaminazione da PFAS in Veneto?
M.M Lo studio sulla contaminazione da PFAS è partito nel 2019, prendendo in considerazione luoghi e abitanti in modo sistemico, ma già dal 2013 l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (Arpa) ha condotto studi per conoscere l’entità di questa contaminazione. Nel 2017 la comunità e il mondo accademico ne sono venuti a conoscenza, precisamente quando è stato avviato il biomonitoraggio per valutare i livelli della sostanza nel loro sangue. Noi ne abbiamo indagato nello specifico le conseguenze psicosociali.
Qual è stato il vostro campione di riferimento?
M.M In questo biomonitoraggio è stata chiesta la collaborazione ai cittadini, sottoposti alla sorveglianza sanitaria — viene chiesto loro di collaborare tramite l’analisi del proprio sangue per evidenziare la concentrazione e i livelli di questa sostanza. In questo modo abbiamo iniziato a conoscere questa vicenda a livello collettivo, con un progetto all’interno dell’Università degli studi di Padova avviato qualche tempo dopo, nel 2019.
Qual è la storia della contaminazione da PFAS in Veneto?
M.M Nel 2017 abbiamo avviato il biomonitoraggio della sanità pubblica per capire l’entità, ovvero quanto prodotto chimico ci fosse nei corpi delle persone. PFAS è una sostanza chimica che non si trova in natura, è stata prodotta artificialmente. Miteni proveniva dalla ex Rimar, Fabbriche Marzotto, che nel boom economico avevano avviato studi di laboratorio sull’impermeabilizzazione dei tessuti. Era stata così prodotta questa sostanza, PFAS — in chimica se ne trovano molteplici, non c’è solo un PFAS: è molto resistente nell’ambiente, non si spezza con facilità e non è biodegradabile. Nel corpo funziona ad accumulo: una volta assunta rimane all’interno del corpo e interferisce con il suo funzionamento.
Quali sono le aree geografiche maggiormente coinvolte?
M.M Le aree coinvolte sono le province di Vicenza, Verona e Padova. C’è una cartina colorata suddivisa in 3 zone: rossa, gialla e verde — e anche arancione, su cui si dibatte ma non si dice molto. La contaminazione è stata circoscritta, però è anche vero che l’acqua corre nel sottosuolo e col tempo diventa sempre più difficile intercettare quali siano i confini. Sono stati riconosciuti dapprima 21 comuni coinvolti nell’area rossa, poi estesi a 30.
L’area rossa è quella che dà un indice di prossimità più stretto rispetto alla contaminazione e scende dal nord di Vicenza, e che coincide con la sede ex Miteni. La parte residuale di questo prodotto chimico via via è andata a inquinare una falda che grossomodo, per ampiezza, è larga quanto il lago di Garda.
Questa falda acquifera alimenta anche i flussi di acqua domestica e degli acquedotti, ed è stata la prima fonte diretta di inquinamento per gli abitanti, che usavano l’acqua del rubinetto per bere, cucinare e per irrigare gli orti. E anche le imprese usavano acque di canali e fiumi per gli animali, o per innaffiare prodotti vegetali.
Quante sono le persone coinvolte?
M.M Attualmente si parla di circa 350 mila persone direttamente coinvolte nella prossimità più immediata della contaminazione, ma sono cifre destinate a salire: arriveremo a circa 800 mila persone contaminate in modo diretto.
Quali sono le conseguenze della contaminazione?
M.M Le conseguenze le abbiamo notate negli Usa con il disastro Dupont. La letteratura medica e accademica oggi individua uno spettro di patologie associate ai PFAS: infertilità maschile, aborti, ma c’è ancora uno statuto d’incertezza rispetto a questa ricaduta. Non sappiamo ancora come queste sostanze agiranno nel corpo delle persone in futuro.
Nel vostro studio parlate di “costi indiretti” della contaminazione.
M.M Nel nostro studio parliamo di conseguenze psicosociali: costi indiretti, che non sempre — anzi, raramente — vengono indagati. Oggi la salute non viene più indicata come assenza di malattia, ma coinvolge una sfera molto più ampia della persona: si parla di qualità della vita e di benessere psicosociale. Noi studiamo la relazione con l’ambiente, e quali sono i fattori che rendono la qualità della vita negativa. Abbiamo evidenziato una serie di fattori che aggravano il benessere di queste popolazioni. È una sorta di dinamica all’interno delle comunità e dei cittadini su come far fronte a questo tipo di problema, sulle mancanze che ci sono state, sulle situazioni che potevano essere mitigate. C’è necessità di far fronte a questo evento apportando un sostegno psicosociale che oggi non c’è, e che potrebbe in un certo senso sostenere la popolazione in un processo ahinoi molto lungo, anche negli anni a venire. Ci sarà una bonifica, ma questo comporterà tempistiche dai tempi non certi.
Qual è stato l’approccio della stampa e dell’opinione pubblica?
M.M: Non si è intervenuto tempestivamente come in altri tipi di disastri. La parte fondamentale di un disastro è informare e il diritto di sapere. Se andiamo a interpellare persone in Veneto o poco fuori, ci dicono che non sapevano niente di questo evento.
A.Z: I PFAS sono ovunque, non è una vicenda locale. I media hanno trattato questo avvenimento a livello locale, ma con un respiro affannoso a livello nazionale. I PFAS pongono una questione a livello nazionale: nessuno è immune da queste sostanze, sono nelle padelle antiaderenti, nei tessuti. La vicenda che si dischiude con questo processo ha una portata molto ampia. Seveso è famosa nel mondo perché ha trasceso la sua territorialità, arrivando a toccare la comunità europea, con la Direttiva Seveso. La vicenda PFAS in Veneto va dischiusa completamente per capirne la portata. I PFAS sono stati trovati addirittura negli orsi polari, non è controllabile, non a caso vengono chiamati forever chemicals, chimici perenni.
Le acque sono tuttora contaminate?
M.M: Sì, esattamente. Ci sono state iniziative della regione sull’applicazione di filtri all’acqua domestica e all’acquedotto per farla arrivare depurata nelle case, ma non è una questione risolta da questo punto di vista. Il problema permane, anche con una tematica di sfiducia nei confronti delle istituzioni, che non hanno informato adeguatamente la cittadinanza soprattutto nei primissimi momenti dell’inquinamento, e non sono intervenute sul dare quel tipo di informazione che consente azioni di coping per far fronte al disastro stesso.
Possiamo paragonare l’evoluzione della contaminazione del Veneto alla vicenda Seveso?
M.M C’è molta analogia con la vicenda del Seveso e sì, era una comunità totalmente impreparata al disastro e non ha saputo far fronte al disastro stesso, quando avrebbero dovuto essere le istituzioni a informare in prima linea.
– leggi anche: Quarant’anni dopo il disastro della diossina parte 1, parte 2, parte 3
A.Z Se andiamo a leggere le vecchie cronache di quegli anni, si legge che i responsabili della Regione Lombardia dicevano “Seveso sarà un case study.” Non solo Seveso è diventato un case study per la Normativa Seveso, ma ha fatto scuola anche rispetto a che cosa facciamo davanti alla diossina, come la affrontiamo. Non dimentichiamoci che in quel periodo si chiedeva consulenza ai paesi attaccati con la diossina per i bombardamenti americani. Nel caso Seveso, è rimasto nella storia il consiglio di lavare tutto con il sapone di Marsiglia, come se fosse in grado di lavare via la diossina dai corpi e dai luoghi, e qualcuno lo fece.
Nel caso della diossina, tuttavia, c’era anche qualcosa a livello somatico che permetteva di percepire il danno, la cloracne — ma pensiamo a tutta la questione delle dinamiche, anche ideologiche, a Seveso sugli aborti. Sappiamo che chi ha praticato l’aborto lo faceva in funzione di un’aspettativa, ma vediamo che c’era molta difficoltà sull’assumere una decisione in un contesto di incertezza. Perché non c’era la certezza che quei feti fossero contaminati e con patologie molto gravi. La paura. Credo che anche la vicenda PFAS abbia queste caratteristiche tipiche dei disastri lenti e cronici — non come un terremoto, che dà subito un’idea del danno fatto e indica da subito che cosa va fatto per rimediare.
Torniamo alla comunità interessata dalla contaminazione PFAS in Veneto: cosa avete potuto osservare a livello di consapevolezza?
M.M Si tratta di una comunità che dall’oggi al domani ha dovuto affrontare una situazione drammatica, con un capovolgimento totale del proprio stile di vita — si poteva pensare a sversamenti, ma mai avrebbero pensato che questa contaminazione fosse così estesa e ne fossero stati vittime per così tanti anni. Patrizia, una mamma NOPFAS, ci ha detto che la popolazione non è stata informata di questa situazione fin dai primissimi momenti, che non sapevano di usare un’acqua altamente contaminata, e per loro non è stata possibile nessun tipo di scelta. Le persone coinvolte dicono che è stato leso il loro diritto di sapere e di portare avanti poi delle scelte per il proprio bene, per la propria salute, per la qualità della vita per sé e per i propri cari.
Quali sono gli effetti psicologici della contaminazione sulle persone coinvolte?
A.Z Qui siamo davanti a un disastro ambientale dove la mano umana ha una responsabilità importante, ma distribuisce i suoi effetti nel futuro, con un grado di incertezza molto marcato. Non c’è da stupirsi che molti cittadini non vogliano quindi sapere nulla dei PFAS. È una forma di negazione mista a protezione: se io riconosco che ho subito questa contaminazione — cosa evidente e palese — non posso nasconderla ma devo farvi fronte, mi impegna. C’è la paura di non essere all’altezza del pericolo di fronte a noi. Questa paura genera altra paura, paura di dover rimettere in discussione tutta quanta la propria esistenza. Pensiamo a un’area dove c’è il chilometro zero, attività tipica di questa zona: pensiamo a un agricoltore che ha investito tutto sé stesso in queste zone e prodotti. È evidente che fare i conti con PFAS nell’acqua, che poi utilizza nei campi e per le bestie — e che entrano nella catena alimentare — vuol dire fare i conti con un disastro economico ed esistenziale. Non stupisce che l’essere umano, in base ai suoi diversi interessi e paure, possa denunciare, minimizzare, oppure negare.
Qual è il punto di vista della psicologia sociale sui disastri ecologici?
A.Z: Parlare di disastro da un punto di vista psicosociale vuol dire occuparsi di esseri umani e renderci conto che un essere umano è incorporato all’ambiente. Colpire l’ambiente vuol dire colpire la persona. Un terremoto: l’elemento naturale offende una comunità, ma anche se non riusciamo a prevedere un terremoto sappiamo esattamente cosa provoca.
Un disastro come questo fa in modo che gli esseri umani si aggreghino, nasce quella che si chiama in letteratura comunità terapeutica. C’è il tema della ricostruzione, infatti c’è grande unità da parte dei cittadini.
Nel caso dei PFAS invece parliamo di comunità corrosive, quelle comunità attraversate da un fatto negativo, dove ci sono delle difficoltà: c’è chi è tacciato di essere un allarmista perché ha denunciato, o chi ha interessi economici e tende meno a denunciare. Guardare a un disastro dal punto di vista psicosociale significa gettare uno sguardo dentro le comunità, guardare che cosa accade ai rapporti tra le persone e ai loro progetti esistenziali. In questi casi gli esseri umani sono derubati della progettualità: abbiamo riscontrato che le persone si chiedono se sia opportuno trasferirsi, lasciare la propria casa e andare altrove. Una madre ci ha detto durante un’intervista: “Ogni albero è come mio figlio, perché li ho piantati quando sono nati i miei figli. Abbandonare questa terra significa per me rompere l’unità familiare.”
Queste sostanze, i PFAS, agiscono a livello endocrino: possono minare il desiderio di maternità, la progettualità familiare. È altrettanto vero che queste problematiche attraversano anche le generazioni: queste sostanze si depositano nell’organismo. Le madri hanno trasmesso PFAS attraverso l’allattamento ai figli, o con le pratiche ecologiche, come l’utilizzo dell’acqua del pozzo.
Come sta reagendo la comunità?
M.M: Abbiamo individuato alcune fasi del senso comunitario: all’inizio ha prevalso la sensazione di dover stare fermi, alla scoperta del disastro, in un mondo che si capovolge. Non avendo risorse cui attingere nell’immediato, la risposta è una forma di immobilità. Via via però si prendono contatti con alcune forme di conoscenza. Alcuni membri della comunità si sono documentati su esperienze analoghe in altre parti del mondo. Dopo c’è la fase dell’agglomerazione: quando le persone iniziano a parlarsi e si formano i primi gruppi spontanei. In particolare le mamme, che hanno iniziato a informarsi e a studiare. Non si tratta di attivismo in senso stretto. Anche i medici di base erano ignari di questa situazione. L’attivismo è servito per avviare le prime trasformazioni personali e collettive: questi gruppi, fondamentalmente di genere e femminili, hanno trovato un obiettivo ancora più grande. Questa causa dicono di portarla avanti per i figli.
Un sorta di macrofamiglia.
M.M Sì, hanno stretto contatti anche con mamme in altre parti del mondo e in Italia, come ad esempio mamme della Terra dei fuochi, con una prospettiva oltre il qui e ora. Spesso in questo genere di disastri si vede solitamente l’evento nel presente e si tende a dare una visione di causa-effetto: in questo processo vengono alla luce eventi negativi che possono infliggere dolore, e alcuni punti negativi non vengono presi in considerazione. I fattori cumulativi: faccio riferimento ad esempio alle preoccupazioni economiche, come la perdita delle proprietà perché non possono essere vendute a un prezzo di mercato, perché subiscono lo stigma dei territori contaminati. Dall’altra parte poi le istituzioni non danno un sostegno adeguato: in questo senso si sentono abbandonati. Anche il biomonitoraggio si rivela negativo, perché ti porta a conoscenza del livello delle sostanze nel corpo. È un lato di conoscenza ma anche una situazione infausta.
È possibile risanare le ferite di queste comunità e guarirle?
A.Z: Abbiamo lavorato sulla giustizia ambientale: c’è chi ha agito, chi ha subito l’evento, le vittime, e c’è la pubblica opinione, la comunità allargata. È evidente che all’interno di questa triangolazione sia importantissimo il dopo, il cambiamento. La violenza segnala un cambiamento biografico per cui o si va avanti facendo i conti con quello che è accaduto, o si pratica la rimozione. Oggi siamo ancora in uno stato di incertezza rispetto al riconoscimento delle vittime. Qui gioca un piano importante l’azione delle istituzioni, il processo – l’agorà pubblica dove lo statuto e la parola permettono di dare voce, e a un pubblico di ascoltare. L’avvio del processo permette di dire a queste persone “non eravamo isteriche, non eravamo pazzi.” Questo è un primo passo del riconoscimento delle preoccupazioni, l’esito del processo sarà determinante per riorganizzare la comunità.
Ci sono tanti modi per superare questo trauma, anche in modo collettivo, con la memoria o a livello individuale e familiare: non tutti hanno subito lo stesso trauma e hanno le risorse per affrontare l’accaduto.
segui Marta su Instagram




