Il G8 di Genova è stato il “trauma psicopolitico” di una generazione
La violenza del G8 non è iniziata e finita in quei giorni: ne abbiamo parlato con gli psicologi Marialuisa Menegatto e Adriano Zamperini, che hanno lavorato per la Corte europea dei diritti dell’uomo sulle torture della polizia italiana a Genova

La violenza del G8 non è iniziata e finita in quei giorni: ne abbiamo parlato con gli psicologi Marialuisa Menegatto e Adriano Zamperini, che hanno lavorato per la Corte europea dei diritti dell’uomo sulle torture della polizia italiana a Genova
Sono passati vent’anni esatti dal G8 di Genova, “la più grave sospensione dei diritti democratici in un paese occidentale dopo la Seconda guerra mondiale” secondo Amnesty International. Così grave che, ancora oggi, la società italiana e coloro che vissero quei giorni e subirono quelle violenze non sono riusciti a elaborare del tutto quell’evento. In questi giorni il dibattito pubblico è tornato a occuparsi di quei giorni, ma sembra difficile curare del tutto una ferita inferta dallo stato ai suoi stessi cittadini senza un percorso di presa di coscienza da parte delle istituzioni e di chi ebbe delle responsabilità mai riconosciute.
Abbiamo parlato delle conseguenze psicosociali del G8 con la dottoressa Marialuisa Menegatto e il dottor Adriano Zamperini. Menegatto è una psicologa e ricercatrice, coordinatrice didattica e scientifica per il master Sicurezza urbana e contrasto alla violenza dell’Università degli Studi di Padova; Zamperini è docente di Psicologia della violenza, Psicologia del disagio sociale e di Relazioni interpersonali allo stesso ateneo. Insieme hanno presentato una relazione tecnico-scientifica per la Corte europea dei diritti dell’uomo sulla valutazione dei ricorsi presentati dalle vittime delle torture della polizia italiana. Sono inoltre autori di Cittadinanza ferita e trauma psicopolitico. Dopo il G8 di Genova: il lavoro della memoria e la ricostruzione di relazioni sociali, in cui si cerca di arrivare in profondità nell’analisi delle premesse e delle conseguenze di quei giorni tragici.

Dott.ssa Menegatto, dott. Zamperini, iniziamo subito dal perché avete deciso di condurre uno studio di questo tipo sul G8 di Genova. Come descrivereste il contesto sociale di quei giorni di luglio del 2001?
Zamperini: Ci occupiamo da sempre di forme di violenza, protesta e contrasto sul piano collettivo. Al tempo, il G8 cadeva all’interno di un movimento molto importante a livello mondiale, connotato in quel periodo da proteste molto accese — non dimentichiamo che prima ci fu Seattle. C’era urgenza di voci alternative a quelle dei potenti di turno, e c’erano anche molte problematiche legate alle dinamiche di piazza. Sin da subito abbiamo seguito le vicende anche perché prima ancora che accadesse tutto avevamo attenzionato e iniziato ad analizzare quelli che a nostro avviso erano i preparativi di una battaglia. Tutto l’aspetto organizzativo del G8 non pareva solamente un problema di ordine pubblico: emergeva in modo netto e puntuale l’idea che ci si preparasse a un vero e proprio scontro fisico. Le avvisaglie circolavano già in diversi eventi accaduti nel mondo in quel periodo. Soprattutto, erano legate a un nuovo modo di fare protesta, che sappiamo essere – per lo meno nei sistemi democratici – abbastanza addomesticata: non c’è vera e propria repressione ma un intervento a livello spaziale sui luoghi dove la protesta si svolge, che risulta spesso in un conflitto. A Genova c’erano molte tensioni riguardo a dove fosse permesso protestare, e c’era questa sorta di roccaforte – il castello inviolabile, la zona rossa – dove stavano i potenti, e chi protestava non poteva accedervi: questi e molti altri erano chiari segnali di preparazione a un potenziale conflitto aperto sul campo. Il libro giunge 10 anni dopo gli eventi di Genova e raccoglie tutto il lavoro che c’è stato nel mezzo. Come studiosi abbiamo scelto di non essere a Genova, in modo da mantenere il distacco necessario per non essere travolti dall’onda emotiva. Volevamo poter fare domande scomode a tutti: a chi in qualche momento indossava una divisa, ma anche a chi protestava per le strade.
Riguardo alle conseguenze sui singoli e sulla collettività a livello psicologico dei fatti del G8: cosa intendete quando parlate di ferite e sofferenza collettive, e in che modo si manifestano? È possibile dire che abbiano prodotto cambiamenti sociali non solo negli individui ma anche nei movimenti e nelle cosiddette dinamiche di piazza?
Zamperini: Per capire gli effetti di una violenza dobbiamo capire cosa c’è stato prima. Osserviamo quello che accade tra un gruppo di attivisti, di persone abituate a stare in piazza e a fronteggiare la polizia nelle manifestazioni — da entrambe le parti ci si aspetta che qualcosa, anche di violento, possa accadere. Per questo si indossano caschi, si lanciano provocazioni, e la polizia può essere più o meno pronta a rispondere: le parti sono preparate allo scontro anche fisico. A Genova è accaduto tutt’altro: sicuramente c’erano delle componenti organizzate e preparate allo scontro, ma c’era una moltitudine di persone che in molti casi erano anziane, donne, boy-scout, religiosi. Molti di questi gruppi si trovavano per la prima volta in piazza, non erano preparati allo scontro e a reggere tutto quello che avrebbe potuto accadere. Le grandi conseguenze della violenza di Genova sono fortemente legate a questo elemento di mancata attesa di una violenza che non è pensata come possibile. Che una donna, con le mani alzate, venga colpita ripetutamente con un manganello è una cosa impensabile. Così come non ti aspetti di essere svegliato dalle manganellate mentre stai dormendo in una scuola, e quindi non ti aspetti la Diaz, e non ti aspetti di finire in quel buco nero che è stato Bolzaneto, dove subisci le più profonde angherie, violenze e umiliazioni. Dunque le più profonde conseguenze legate a questa violenza sono riconducibili al fatto che hanno colpito una moltitudine di cittadini che si pensava come soggetto di diritto, e in quanto tale non si aspettava che quello che è accaduto potesse accadere. Questo provoca una cesura molto netta: se sono preparato a reggere la violenza le conseguenze saranno molto più attenuate, ma non è questo ciò che è avvenuto a Genova nel 2001.
Menegatto: Per descrivere ciò che è successo abbiamo dovuto coniare un nuovo termine in ambito accademico, introducendo i concetti di cittadinanza ferita e trauma psicopolitico: sono gli elementi che hanno caratterizzato quei giorni, generati dalla frattura tra cittadini e forze dell’ordine, della frattura di un patto sociale, una ferita di cittadinanza ancora aperta. Le regole, le norme, il potere sono il nucleo centrale attraverso cui la democrazia stessa e la cittadinanza si esprimono, e devono agire per presiedere e garantire un certo ordinamento e funzionamento della vita collettiva. La manifestazione di Genova in questo senso doveva essere pacifica e sicura: un precipitato normativo che ha fallito. Al centro c’erano cittadini che si aspettavano di essere protetti.
Invece in quei giorni le persone ferite non si rivolgevano al pronto soccorso perché temevano di essere identificate e incarcerate e questo, in uno stato democratico, è una follia. È la vicenda che hanno raccontato molti manifestanti anche nei confronti delle forze dell’ordine. Ci si è ritrovati in un sistema violento che ha abusato e non ha tutelato i diritti fondamentali proprio di uno stato democratico, che ha deluso l’aspettativa di protezione e rotto con violenza il patto democratico e di cittadinanza.
La violenza del G8 di Genova non è stata una violenza iniziata ed esauritasi in quei giorni, ma continuata negli anni successivi, dal momento che ha coinciso con il diniego delle istituzioni che hanno silenziato quegli avvenimenti o addirittura promosso gli agenti coinvolti nelle violenze. Inoltre i processi sono iniziati molto tempo dopo gli eventi e la giustizia ha faticato a fare il suo corso.
Una parte di trauma ha il suo riscontro in sintomatologia clinica in termini di ansia, angoscia, depressione, attacchi di panico, ma una parte riguarda la sfera politica — la sfiducia e la paura nei confronti della politica e della polizia, della divisa. Paura ed evitamento: le persone coinvolte nelle violenze successivamente avevano paura dei lampeggianti e delle sirene della polizia e delle ambulanze, e persino la divisa di un controllore del treno faceva paura. In tutto questo percorso, politica e istituzioni italiane non hanno mai avviato un processo di riconciliazione con la propria cittadinanza. Si tratta prima di tutto di un caso di disabilità politica.
Spesso si dice, e si è detto anche riguardo il G8, che il tempo curi le ferite e lenisca la sofferenza. È stato così?
Menegatto: Purtroppo il tempo non ha curato le ferite. Abbiamo trovato tra i soggetti molti aspetti in comune alle vittime dell’Olocausto: è una sofferenza che può trasformarsi, ma la ferita dura per sempre. L’esito di questa ferita dipende dalle caratteristiche di una persona e dalle sue capacità di elaborazione del trauma. Il tempo, in questo caso, ha remato contro. In molti casi la sofferenza a livello di sintomi si è manifestata dopo anni, con casi di individui che hanno sviluppato attacchi di panico molto tempo più tardi. Ci siamo trovati di fronte a una violenza che aveva un bersaglio indistinto, che colpiva in modo indiscriminato un insieme di persone — i manifestanti — percepite come appartenenti a un gruppo, in cui non era tanto ciò che facessero, ma ciò che erano a essere decisivo per quello che avrebbero subito.
C’è continuità emotiva, una sorta di contagio emozionale, tra chi era presente e chi non si trovava a Geova esattamente per questa ragione: la consapevolezza che al posto di quei manifestanti feriti avrebbe potuto esserci chiunque ha provocato un profondo senso di inquietudine e smarrimento. Improvvisamente quella testa rotta è anche la tua, e per una semplice contingenza non è la tua, ma quella di un altro. Anche per questo dopo Genova si assiste a un ritiro della protesta, a un ritiro della voce collettiva, un collasso: è stata colpita duramente la partecipazione dal basso, partecipazione spesso richiesta alla cittadinanza ma in quei giorni completamente parcellizzata. La difficoltà successiva è stata quella di ricomporsi a fronte della violenza subita, ma non sempre è avvenuto e raramente del tutto.
Cos’è un trauma psicopolitico e cosa significa che il G8 di Genova andrà a “conficcarsi nel futuro”? Lo scrivevate dieci anni fa.
Menegatto: Si tratta di percorsi difficili di riconciliazione: sapevamo che le cose non si sarebbero risolte subito e avrebbero richiesto molto tempo. Nel tempo mettere assieme i pezzi è molto importante per le vittime migliaia e migliaia di vittime, dirette e indirette: non solo i presenti, ma anche il “pubblico,” gli spettatori, i genitori dei ragazzi che non sono tornati a casa per giorni dopo quegli eventi. Solitamente traumi come questo vengono compresi sotto il termine PTSD, che è piuttosto trasversale e episodi di forte trauma e di qualunque tipo. Tuttavia i riscontri empirici raccolti non soddisfavano completamente questa diagnosi, che risultava limitata, e per questo motivo abbiamo coniato il termine “trauma psicopolitico”. L’elemento politico era troppo importante per non essere parte integrante della diagnosi. Abbiamo ampliato l’etichetta per la caduta di sfiducia nei confronti di rappresentanti dello stato, che avrebbero dovuto suscitare altre emozioni.
Zamperini: Sono passati vent’anni. Al di là di quelli che sono i percorsi giuridici collettivi e individuali,se ragioniamo su cosa è oggi il G8 di Genova vediamo che ormai è una formula linguistica diventata sinonimo di abusi, di autoritarismo e violenza di stato. Prendiamo il caso degli abusi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di cui si è recentemente parlato e il cui dibattito ha coinciso solo in modo accidentale con l’anniversario del G8, ma che a quegli eventi, e a Bolzaneto, è stato in più occasioni assimilato: questo ci dimostra quanto ormai G8 Genova sia una rappresentazione simbolica sistematica di abusi ingiustificati. Il G8 di Genova è dunque un evento che resta come frattura del nostro paese, e anche a livello europeo visto il numero di partecipanti stranieri. È una vecchia ferita che quando cambia il tempo duole ancora. Spesso si cerca di trovare un momento dove poter elaborare anche collettivamente gli avvenimenti drammatici, anche sui luoghi fisici dove questi si sono manifestati: col G8 non è accaduto, anche questo è stato negato. Basti pensare anche al vilipendio del cippo in memoria di Carlo Giuliani a Piazza Alimonda. A Bolzaneto e alla Diaz si è fatto l’impossibile per cancellare quanto era successo. Ancora oggi Carlo Giuliani è un morto per la famiglia, ma non è un nostro morto. C’è ancora una sorta di ostracismo nei suoi confronti, è come se fosse un morto che non ci appartiene, come se riguardasse solo la famiglia, come se fosse una faccenda privata. Ma questi avvenimenti sono collettivi. Oggi il G8 sconta questa mancanza. Dopo 20 anni, l’incapacità di affrontare pubblicamente questi avvenimenti, trattati sostanzialmente solo in ambito giuridico, lascia aperte molte problematiche.
[wonderplugin_video videotype=”mp4″ mp4=”https://under.media/multimedia/G8-01.mp4″ webm=”” poster=”” lightbox=0 lightboxsize=1 lightboxwidth=1920 lightboxheight=1080 autoopen=0 autoopendelay=0 autoclose=0 lightboxtitle=”” lightboxgroup=”” lightboxshownavigation=0 showimage=”” lightboxoptions=”” videowidth=1920 videoheight=1080 keepaspectratio=1 autoplay=0 loop=0 videocss=”position:relative;display:block;background-color:#000;overflow:hidden;max-width:100%;margin:0 auto;” playbutton=”https://thesubmarine.it/wp-content/plugins/wonderplugin-video-embed/engine/playvideo-64-64-0.png”]
Video: Indymedia, per concessione di Mark Covell
In che arco di tempo sono state condotte le interviste?
Zamperini: Sono state realizzate in tempi diversi nell’arco di 10 anni. All’inizio è stato difficile avvicinare i soggetti, anche per via dell’11 settembre che ha spostato e spazzato via l’attenzione dal G8 di Genova, facendolo sparire per qualche tempo dall’orizzonte del dibattito politico e di attualità per riemergere solo più avanti, con l’inizio dei processi. All’inizio le persone si sono ritirate nella propria realtà e intimità. Poi, grazie anche all’azione dei processi, è stato possibile iniziare un percorso di giurisprudenza terapeutica: i processi a volte hanno anche questa funzione, che va al di là dell’accertamento della verità tout-court, ma che permette alle persone coinvolte di rimettere in moto un percorso importante di condivisione e guarigione. Purtroppo le commemorazioni, come quella di questi giorni, sembrano momenti pensati solo per ricordare ciò che è accaduto, ma non il suo lascito. Noi abbiamo sempre cercato di guardare al presente e al futuro, abbiamo lavorato sul reato di tortura in Italia con Amnesty International e con le persone che hanno vissuto Genova, e questo credo sia il modo di fare memoria, memoria attiva, oltre la lacrimuccia nei momenti di commemorazione, oltre le emozioni estemporanee. Il nostro paese al tempo era senza un ordinamento sulla tortura, e crediamo che un ottimo modo di fare memoria sia prima di tutto portare avanti ciò che è rimasto indietro.
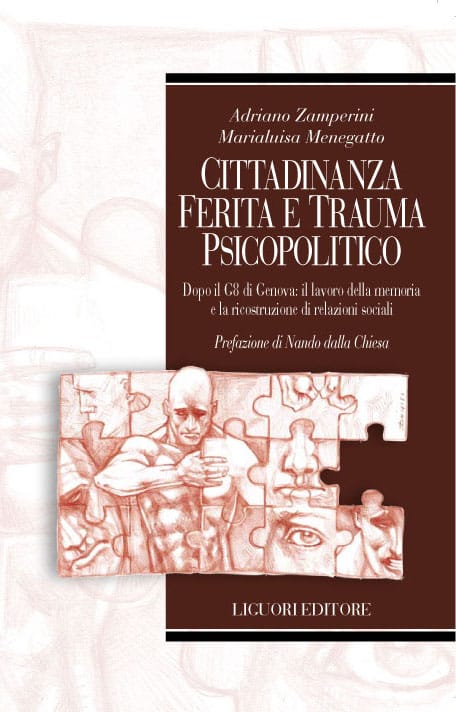
Nel libro parlate di vittime di autoritarismo – impossibile non pensare al lavoro di Stanley Milgram, “Obbedienza all’autorità”. Cosa porta l’essere umano a esercitare violenza su un altro essere umano inerme, sulla base di un ordine impartito? È stato questo che è avvenuto in più situazioni a Genova nel 2001, o si è trattato delle famose “mele marce”?
Zamperini: Ci sono due correnti di pensiero: una ritiene che la violenza sia originata a livello interiore, e un’altra che sottolinea la violenza sia generata da ciò che accade tra le persone. È una distinzione fondamentale. Nel momento in cui la violenza è vista come innata nell’individuo – dove l’esterno è contingente, attiva tendenze già innate – interpretare i fatti e operare cesure nette diventa improvvisamente molto più semplice. Chi adotta questa prospettiva tende a parlare delle cosiddette mele marce, di devianti attivati dal potere che li porta a mettere in atto qualcosa di disdicevole, di cui tuttavia hanno piena responsabilità individuale. C’è un collegamento, ma le persone violente non sono matrioske con una predisposizione genetica alla violenza. Semplicemente degli individui all’interno di una certa situazione possono sentirsi legittimati a compiere delle azioni e ciò che le rende legittimate è che si tratta di qualcosa che viene ordinato, e in qualche modo desiderato. Faccio un esempio: durante il processo di Norimberga fu impossibile trovare il documento in cui Hitler ordinò di mettere in atto la soluzione finale. Ciò lo rende meno responsabile? Chiaramente no. Bisogna anche tenere presente che spesso i subalterni sognano il sogno del proprio comandante, e desiderano compiacerlo. Quando in una determinata situazione si va a creare un contesto di forte polarizzazione, come quello del G8 diviso tra garanti dell’ordine buoni e manifestanti sovversivi e cattivi – chi ha un certo potere si sente legittimato dalle autorità, dalle istituzioni.
La Violenza Diaz e di Bolzaneto è una violenza punitiva, che non ha l’obiettivo di ristabilire l’ordine pubblico. Il G8 di Genova era andato com’era andato, e a fronte di quelle giornate disastrose dal punto di vista dell’ordine pubblico quello che accadde dall’irruzione alla scuola Diaz fu una sorta di tentativo di ripristino dell’asimmetria tra i due poli, di ripristino del potere. Se la coercizione è ammessa in un sistema democratico, deve comunque essere l’esercizio di un potere regolato. Non è ammissibile che nel chiuso di una caserma ci sia chi possa prendersi determinate libertà rispetto al potere regolato. Questo perché il punto è che da una parte e dall’altra ci sono due concittadini. Se non teniamo presente questi elementi e li polarizziamo accade quello che sempre più spesso vediamo accadere nelle prigioni, che paiono essere fuori dalla giurisdizione dello stato di diritto, e dove pare esserci quasi una subcultura organizzativa non allineata allo stato di diritto. Per questo bisogna ripensare il carcere oltre gli interventi palliativi che da anni si mettono periodicamente in essere. Bisogna ripensare quelle leggi che ingolfano il carcere di una moltitudine di persone. Quando si creano identità così polarizzate e do a una delle parti il potere di gestire la controparte attrezzata per farlo con la forza fisica e la violenza, la situazione sospinge i singoli in una determinata direzione. Non c’è in questo una dinamica di meccanismo, bensì una logica dinamica d’impasse dalla quale è difficile uscire, di continua azione e reazione tra le parti, dove quello che fa un individuo dipende da quello che fanno gli altri. Oltretutto, il personale che si trova a gestire dinamiche come quelle del G8 dovrebbe avere una preparazione particolare, anche a livello psicologico e relazionale, per interpretare al meglio la situazione. A Genova non è accaduto: mandarono un po’ di tutto, a gestire una moltitudine abbastanza caotica con disorganizzazione anche interna tra i corpi di polizia.
Dunque sarà mai possibile stabilire – anche semplicemente analizzando comportamenti e dinamiche sociali, vista la mancanza di collaborazione delle forze dell’ordine – se ci fu un ordine delle autorità, e perché fu dato, o se sia stata invece solo conseguenza di un’iniziativa dei singoli o di singoli reparti presenti sia a Diaz che a Bolzaneto?
Zamperini: No. Da questo punto di vista dobbiamo fare un passo diverso: spesso dietro a questa domanda c’è una logica di tipo giuridico, che deve dare ad ogni azione un attore. Ma dobbiamo ragionare secondo una responsabilità di sistema, non individuale. Il sistema con cui è stato confezionato l’evento G8, un sistema belligerante che aveva già prima di verificarsi un’estrema possibilità di sfociare in violenze e conflitti aperti. Non c’è una singola responsabilità, ma una responsabilità sistemica, politica e collettiva. Rispetto ai singoli è stato decisivo solo il peso di autorità che queste potevano esercitare in quella situazione. Il sistema evento G8 ha grandi responsabilità sull’esito degli eventi. Prima del G8 si faceva collezione dei sacchi neri per i cadaveri, prima del G8 circolavano messaggi che parlavano di sacche di sangue infetto da HIV che sarebbero state usate durante la manifestazione come armi: tutto questo prepara un terreno di conflitto. Oltretutto una città come Genova è difficile da gestire, perché è verticale, e perché ha tutta una serie di problematiche anche a livello urbanistico che la rendono sicuramente una delle città più sbagliate in Italia dove realizzare un evento del genere. A monte c’è quindi una enorme questione di responsabilità. Sarebbe auspicabile innalzare e allargare lo spettro di visione e analisi dei fatti: non fu un problema di mele marce, ma di sistema, di relazioni entro cui i singoli attori sono stati gettati. E in un sistema già pensato come conflittuale, è scontato che a un certo punto il conflitto si manifesti. Se invece — come avrebbe dovuto essere per il G8 — si toglie conflittualità al sistema, si abbatte enormemente la possibilità che un conflitto si manifesti. Possiamo diminuire la probabilità che gli eventi violenti si manifestino promuovendo un sistema che valorizzi altre azioni, positive e di dialogo. Ma giungere davvero a capire l’eziologia della violenza nei singoli casi, soprattutto in dinamiche di gruppo come queste, rimane estremamente complicato.

Il nemico a Genova in quei giorni aveva un volto e una fisionomia ben definita: il cosiddetto black bloc. Cosa ha comportato questa narrazione?
Menegatto: il black bloc è stata la figura egemone verso il quale è stata polarizzata tutta l’attenzione. è servito per generalizzare l’individuazione del nemico anche nella stessa cittadinanza, nonostante fosse minoritario rispetto alla compagine variegata dei cittadini presenti in quei giorni. Il cittadino divenne dunque il nemico. A Genova fu anche scelto di non fare un servizio d’ordine, e questo in cortei di quelle dimensioni diventa problematico, perché dal punto di vista spaziale ciò ha contribuito a creare un effetto alone, ad avere un nemico che diventava una macchia nera che ha contagiato e spesso deviato e corrotto l’immagine della grande protesta a Genova, sia a livello di narrazione che a livello mediatico e della memoria di quei giorni.
In quei giorni e per molto tempo dopo abbiamo assistito a vere e proprie strategie di delegittimazione delle vittime delle torture, soprattutto dentro la caserma di Bolzaneto.
Zamperini: La delegittimazione è una strategia relazionale e psicologica violenta. In qualsiasi sistema oppressivo, come è stato quello di Bolzaneto, le persone sono degradate. In un ambiente simile viene allontanato dalla coscienza morale qualsiasi tipo di interrogativo — e più si riesce a far regredire le persone in uno stato quasi animale e di negatività, più diventa semplice accettare ciò che si sta facendo. Se si tratta un manifestante come un animale, dicendogli di essere un cane e di comportarsi come tale e lo si prende a calci perché non riesce bene a muoversi per le percosse subite finché non si muove bene a quattro zampe, e poi gli viene chiesto di abbaiare, in qualche modo lo si fa regredire verso il regno animale. Si arriva a una sorta di compiacimento da parte di chi guarda questo manifestante costretto a fare il cane, e quasi si arriva alla convinzione che lo sia, distanza che permette di accettare la tortura che si sta inferendo al soggetto inerme. A Bolzaneto oltre alla violenza fisica c’è stata una forte violenza psicologica per sottrarre diritti alla persona, un furto di umanità che fa spesso regredire verso un regno animale, o verso i margini della comunità centrale. Questo ha ripercussioni molto pesanti sull’individuo, che si protraggono anche nel tempo.
Parlate di Genova come di una città che in quei giorni era un “dispositivo di potere”: cosa significa?
Zamperini: La città è diventata un dispositivo di potere per come è stata organizzata spazialmente, con la roccaforte interna recintata dove stavano i potenti e con tutto ciò che era marginale al di fuori di questo confine. Ricorda esattamente la struttura dei castelli medioevali di un tempo, in cui la plebaglia, il popolino, stava fuori dal castello. La città estremamente militarizzata, con una forte simbologia di un potere sovrano che in poco tempo l’aveva recintata trasformandola da un luogo poroso, con spazi aperti e accessibili, in una città dei sovrani: un dispositivo di potere. Gli stessi cittadini residenti all’interno della zona rossa dovevano muoversi attraverso queste porte metalliche che poi finivano tuttavia anche per imprigionare il potente, trasfigurando poi la compagine in una sorta di prigione da entrambe le parti, anche per i potenti. Perché qualsiasi dispositivo di potere, oltre a escludere include, ingloba.

Alla luce di tutto questo, come si pratica la riconciliazione e quali sono realmente le parti da riconciliare? Come si ricostruiscono le relazioni sociali e quanto di questo passa per la sfiducia nello stato e nelle istituzioni?
Menegatto: I percorsi di riconciliazione sono molto lunghi. Non si tratta solo di riconciliare le parti ma di trasformare il conflitto nella mente delle persone a livello psicologico. Anche in questi giorni vediamo che nel ricordare il ventennale ci sono delle voci di lamento, perché Genova sta ancora producendo la sua sofferenza. Non bisogna dimenticare il conflitto ma trasformarlo, per mettere in atto il superamento: la parte che si è resa responsabile delle violenze deve ammettere le proprie responsabilità, chiedere perdono alle vittime, chiedere scusa. È accaduto in moltissime altre situazioni, stabilendo un livello di simmetria tra il potere e i cittadini attraverso il riconoscimento di quanto è accaduto. Questo invece si è verificato raramente per il G8 di Genova, e spesso per iniziative di singoli. I carnefici devono mettere le vittime in condizione di rielaborare i vissuti negativi, di superare la sofferenza, di perdonare. Questo non è mai accaduto per le vittime di abusi e violenze, e forse non accadrà mai, ma rimane l’unica strada percorribile per superare i traumi molto profondi che ancora oggi, a vent’anni dall’accaduto, tormentano coloro che li hanno ingiustamente subiti.
Segui Marta su Instagram
Sostieni l’informazione indipendente di the Submarine: abbonati a Hello, World! La prima settimana è gratis
in copertina: grab da video Indymedia, per concessione Mark Covell. Elaborazione the Submarine




