Sorpresa: il nemico della Lega è ancora il Sud
Lo scopo dell’autonomia regionale è una vera e propria “secessione dei ricchi.” E le regioni, negli ultimi vent’anni, non hanno fatto niente per meritarsi tutto questo potere.

Lo scopo dell’autonomia regionale è una vera e propria “secessione dei ricchi.” E le regioni, negli ultimi vent’anni, non hanno fatto niente per meritarsi tutto questo potere
Giovedì 14 febbraio, alle 19, il Consiglio dei ministri ha discusso la proposta di concedere maggiori autonomie alle regioni che ne hanno fatto richiesta: Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. È l’ultima tappa di un percorso durato decenni, che parte da Umberto Bossi che urla al megafono “Roma Ladrona” e che ha avuto come snodo fondamentale i sedicenti “referendum per l’autonomia” di Lombardia e Veneto, il 22 ottobre del 2017.Al momento, l’approvazione della riforma sembra procedere molto lentamente. In Consiglio dei ministri il Movimento 5 stelle si è opposto: il suo bacino elettorale è radicato soprattutto nel Sud del paese, e il partito non può permettersi di perdere altri voti, specie dopo l’allarmante tracollo delle regionali abruzzesi. Di Maio, presentando un dossier dei gruppi parlamentari sull’argomento, ha detto che si opporrà a qualsiasi provvedimento che crei “cittadini di serie A e di serie B.” Sono stati anche sollevati dubbi sulla costituzionalità sia dell’autonomia sia del modo in cui lo stato dovrebbe assegnare le competenze alle regioni.La concessione dell’autonomia alle regioni sarebbe una svolta epocale per il paese; tuttavia, almeno fino a giovedì, la questione non è stata per nulla al centro del dibattito politico nazionale — a parte in Veneto, dove il discorso pubblico e la stampa sono in fibrillazione da settimane, in una sorta di piccolo conto alla rovescia patriottico. Giovedì sera il sindaco di Milano Beppe Sala, che pure ha sempre guardato con simpatia alle rivendicazioni lombarde di più autonomia, ha chiesto al governo di fermarsi — “discutiamo, fate capire agli italiani di cosa stiamo parlando, perché questa autonomia è avvolta dal mistero e neanche io l’ho capito.”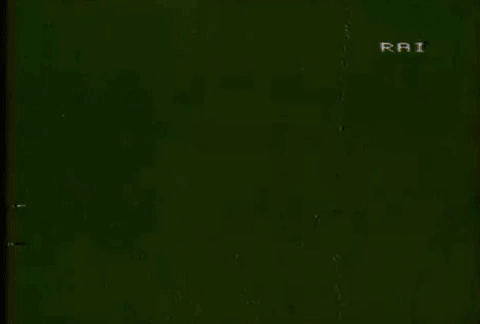
- istituzionale;
- finanziaria;
- ambientale e protezione civile, territorio e infrastrutture;
- economica e del lavoro;
- cultura, istruzione e ricerca scientifica;
- sociale e sanitaria.
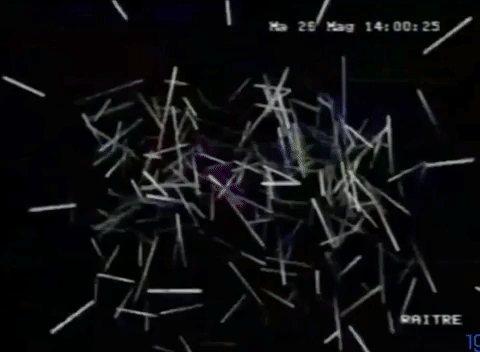
Ovviamente, infatti, più competenze significa più soldi
Il residuo fiscale è una stima della differenza tra tasse pagate allo stato e le risorse che lo stato rigira al territorio per l’utilizzo effettivo. Se lo stato dà meno di quanto prende, il residuo fiscale è negativo. È una stima perché esistono diversi metodi per calcolarlo ed è soggetto a diverse distorsioni. Ad esempio: gli stabilimenti al Sud di alcune grandi aziende settentrionali pagano le tasse al Nord — ma è evidente che danno stipendi e lavoro a persone che non sono loro corregionali. Il residuo fiscale è negativo soprattutto per la Lombardia, ma anche per Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana. Per le altre regioni è positivo o di calcolo incerto, come nel notevole caso del Lazio. Nel caso del Veneto, fin dal referendum del 2017 è stato messo nero su bianco che l’obiettivo ultimo sarebbe stato quello di trattenere il 90% del gettito fiscale perché venga riutilizzato in regione. Nella bozza, da quanto è emerso dalle dichiarazioni di politici come Erika Stefani, ministra agli Affari Regionali, si parla di una possibile “compartecipazione” delle regioni all’importantissima IRPEF, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche, e altre tasse come bollo auto, IRAP, eccetera. Finora, queste richieste avevano trovato l’opposizione netta dei governi e soprattutto del ministero dell’Economia. Ma ora, con la Lega saldamente al governo, il vento è cambiato.È importante farlo notare: tutto questo avrebbe un evidente effetto bomba sul paese e risulterebbe in una vera “secessione dei ricchi.”
Il ragionamento alla base, neanche troppo nascosto, infatti, è che chi è più ricco ha diritto a servizi di maggiore qualità — ed è anche qui che si sollevano i maggiori dubbi sulla costituzionalità della riforma. La quantità di soldi da destinare alle regioni, infatti, verrebbe calcolata e stabilita da apposite “commissioni paritetiche” (che già esistono per le regioni a statuto speciale): è un modo di concepire la democrazia come affare tra privati — nel migliore dei casi tra buoni impiegati o amministratori — che ricorda un po’ il dibattito sui tribunali a porte chiuse compresi nelle bozze dei trattati TPP e TTIP, che avrebbero dovuto regolare i commerci e i contenziosi tra gli stati come liti condominiali multimiliardarie.I soldi da girare alle regioni verrebbero stabiliti da queste entità giuridiche in un primo tempo col criterio della spesa storica, che dopo tre anni verrebbe però sostituito da quello dei “fabbisogni standard.” La decisione presa con la singola regione a porte chiuse prescinderebbe dai bisogni delle altre regioni italiane. In questo modo poi i presidenti delle regioni ricche hanno buon gioco a non presentarsi come razzisti: l’accordo viene semplicemente concluso tra la propria regione e lo stato, le altre regioni — ammesso che non siano popolate da gente incapace e che non ha voglia di lavorare — possono anche loro regolarsi con Roma come meglio credono. L’effetto finale, però, è che chi è ricco ha sempre di più, chi è povero ha sempre meno. È interessante inoltre notare che, prima del calcolo dei fabbisogni standard, dovrebbe essere compiuto un altro calcolo, quello dei “Livelli essenziali delle prestazioni” pubbliche (LEP) che dovrebbero essere garantite sul territorio nazionale, previsto nella riforma del 2001 ma finora mai attuato: come prevedibile, il calcolo dei fabbisogni dei più fortunati è sentito come una priorità rispetto al calcolo dei bisogni di tutti. È ancora più interessante anche notare che questo principio, di fatto, si verifica anche oggi: lo stato per un cittadino spende in media all’anno molto di più al Nord che al Sud — per la precisione, 4.472€ al Sud contro 6.034 al Centro-Nord; 1.606 contro 1.960 solo per la sanità.Su tutto questo progetto di secessione dai poveri grava però una grossa incognita: la Corte costituzionale.
Molti dei provvedimenti che abbiamo elencato, infatti, potrebbero essere bollati come contrari alla carta fondamentale dello Stato — così come del resto molti altri. E, secondo alcuni, l’intera riforma potrebbe essere tacciata di irregolarità — come scrivevamo sopra, sia sul modo che sul merito.Se sul merito tutto è abbastanza chiaro — non si può spaccare lo Stato ancora più di quanto già lo sia, senza un’ulteriore riforma costituzionale — anche le modalità di discussione e di assegnazione delle competenze alle regioni sono a dir poco controverse. Il progetto presentato giovedì in CDM prevede che il compito di discutere e decidere spetti a delle apposite commissioni paritetiche, composte da membri delle singole regioni e del governo, simili a quelle di cui parlavamo poco fa. Il parlamento verrebbe coinvolto solo ad accordo raggiunto per approvare o respingere l’intesa, senza la facoltà di modificarla o emendarla. Il patto così raggiunto durerebbe dieci anni, in cui non sarebbe nemmeno possibile renderlo oggetto di un referendum abrogativo.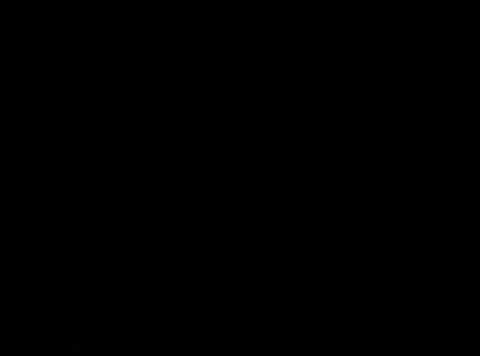
Con l’autonomia insomma si potrebbero riunire le due anime della Lega: quella razzista verso il Sud e quella razzista verso gli “stranieri.”
Abbiamo fatto più volte notare che fatti come quelli di Lodi, dove la sindaca aveva provato ad escludere alcuni bambini extracomunitari dalle mense scolastiche con un cavillo burocratico, sono parte integrante del programma razzista della Lega. Se le competenze per l’istruzione aumenteranno non è difficile immaginare che in Lombardia fenomeni come questo potrebbero diventare più frequenti, più facili da condurre fino in fondo, e magari addirittura normali.La regione potrebbe anche ottenere una maggiore autonomia nella redazione dei programmi scolastici, o nella gestione delle risorse per gli istituti e per le università: non un fatto incoraggiante, vista la ben nota simpatia dell’attuale giunta — e di quelle precedenti — per l’istruzione privata. Ricordiamo anche che la Lombardia è quel posto in cui la giunta è arrivata ad illuminare il Pirellone con la scritta “FAMILY DAY,” e a istituire un numero di telefono per soccorrere i bambini esposti alla bieca teoria del gender.A questo punto è giusto fermarsi e porsi una domanda: ma le regioni cosa hanno fatto per meritarsi tutta questa benevolenza?
? Leggi la seconda parte dell’articolo
***
In copertina: Luca Zaia e Matteo Salvini nel 2015, via Facebook.
Le Gif sono tratte da questo video, che raccoglie alcune sigle dei TG3 e TGR dagli Settanta a oggi.
Segui Stefano su Twitter.
Se ti piace il nostro lavoro e vuoi sostenerci, abbonati alla newsletter di Hello, World, la nostra rassegna stampa del mattino.




