Sei mesi dopo il 4 marzo
La teoria per cui gli elettori si sarebbero stufati in fretta del governo Lega–5 Stelle si è rivelata completamente errata.

in copertina, i migliori anni della nostra vita, elaborazione the Submarine da foto @Montecitorio via Twitter
Tra la rivoluzione di febbraio e quella di ottobre, nella Russia del 1917, sono passati nove mesi. Da noi sono passati sei mesi dalle scorse elezioni — a che punto stiamo?
Sei mesi fa eravamo in diretta a seguire lo spoglio dei risultati elettorali, insieme a tutto il resto del paese. L’esito lo conosciamo: il Movimento 5 stelle è stato consacrato come partito più votato dagli italiani, raggiungendo il 32% dei consensi. Il Pd è rimasto il secondo partito, crollando però al 19%, mentre alla Lega è riuscito il sorpasso del suo teorico alleato Forza Italia, con il 17% delle preferenze rispetto al 13%. Liberi e uguali, la formazione dei fuoriusciti dalla sinistra del Pd, si è fermato poco oltre il 3%. Dopo tre mesi di trattative il governo è stato formato dall’alleanza post-elettorale Movimento 5 stelle e Lega, suggellata grazie al premier cuscinetto Giuseppe Conte.
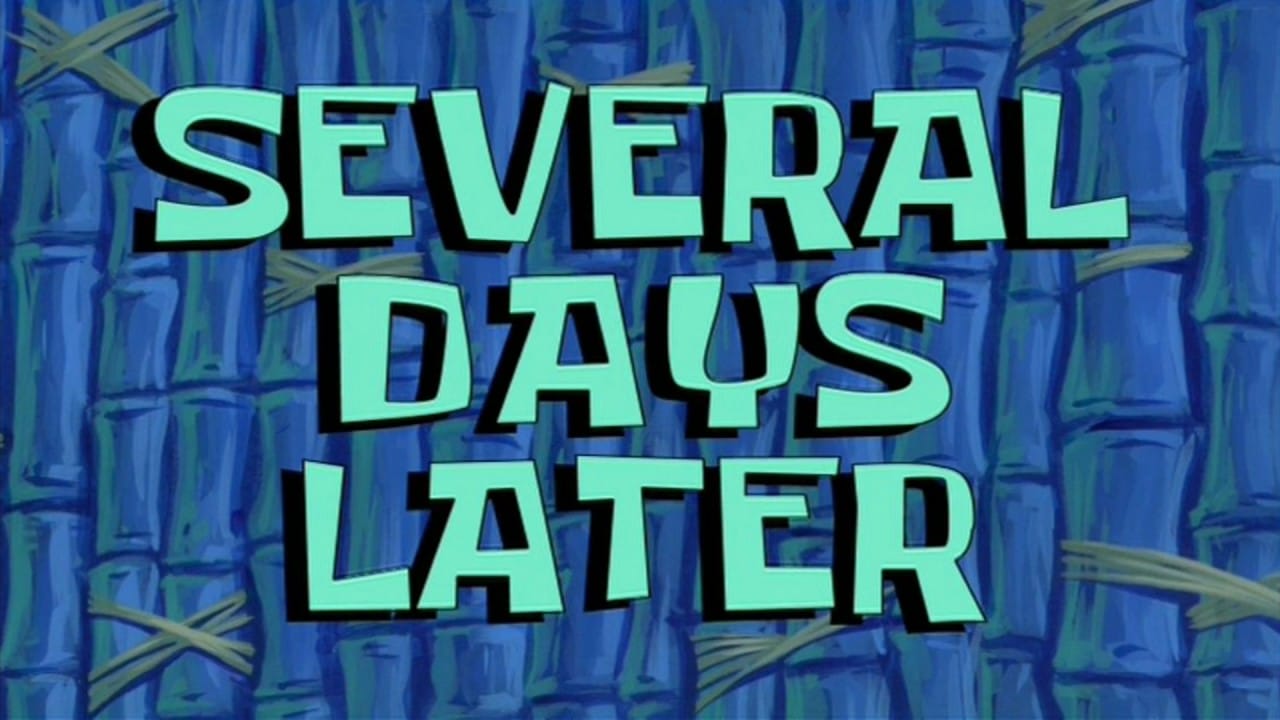
Da allora, però, la campagna elettorale sembra non essere mai finita. Il punto più costante di questi sei mesi è stato il tono di continua tensione nel discorso pubblico, una tensione mantenuta accuratamente alta dal segretario della Lega, Matteo Salvini. La sua comunicazione politica infatti non è mai uscita dal mood elettorale. Salvini ha fatto capire quale sarebbe stata la sua impostazione per questa legislatura già durante le trattative per la formazione del nuovo governo.
Il segretario leghista si è distinto per un comportamento che lo facesse sembrare un uomo forte, con un dialogo pieno di “prendere o lasciare” e scontri istituzionali anche forti. L’esempio principe è il puntiglio sul nome di Paolo Savona al ministero dell’Economia, sul quale il wannabe ministro dell’Interno aveva dato a credere di esser pronto a far saltare l’intera trattativa. In quell’occasione la Lega si lanciò, seguita a ruota dai 5stelle, in un aspro ma breve scontro istituzionale con il Quirinale — ricordate, il minacciato impeachment a Mattarella?

Questa strategia della tensione ha avuto l’effetto di appiattire ancora più a destra il Movimento 5 stelle, il quale si è trovato impreparato a gestire un’alleanza con un compagno che si è rivelato molto ingombrante, nonostante fosse nell’aria già prima delle consultazioni. Il governo che si è formato è un governo di destra: forte con i deboli e complice dei forti, ha scelto come bersaglio e pietra angolare della propria presenza mediatica la presunta “crisi migratoria.” Le vittime di questi sei mesi post-elezioni sono i migranti, che muoiono nel mar Mediterraneo con una facilità drammatica e mai vista prima. Secondo l’UNHCR, quest’anno meno persone provano ad attraversare il mare, ma la frequenza delle morti è salita da 1 vittima ogni 42 migranti nel 2017 a 1 su 18.
Questo martellamento sui migranti è in massima parte farina del sacco di Salvini. Nonostante anche i 5 stelle, nell’anno precedente alle elezioni, si fossero spostati molto a destra sulla questione migratoria — promuovendo ad esempio l’indegno tiro al bersaglio contro le ONG — in questi sei mesi hanno accettato che la Lega dettasse la linea del governo sull’argomento. Per il Movimento 5 stelle si tratta di un errore tattico prima ancora che politico: il partito, precedentemente molto più evanescente tra transumanismo e tecno-ottimismo, oggi non può che essere pienamente inquadrato come un partito reazionario, che usa il linguaggio della destra e si adegua alle politiche della destra. Facendo così cade nello stesso errore dei governi di coalizione degli scorsi cinque anni: perché qualcuno dovrebbe votare un Movimento 5 Stelle, o un Partito democratico, che scimmiotta la destra quando c’è una destra vera? A maggior ragione ora che c’è una destra vera e forte.
Le proposte cardine della campagna elettorale del Movimento infatti sono state tutte rimandate: una su tutte, il reddito di cittadinanza, che Di Maio aveva dichiarato essere la sua priorità e invece è slittato almeno all’anno prossimo. È in buona compagnia: le meraviglie che dovevano arrivare dai tagli dei costi della politica, dall’aumento delle pensioni, dal superamento della legge Fornero, ancora non si sono viste, né sembrano essere prossime a venire realizzate. Alcune misure, come il taglio delle pensioni d’oro, stanno venendo avversate dall’alleato leghista. Perfino le proposte più dimenticabili fatte prima del 4 marzo, come rendere italia.it il portale unico per l’e-commerce dei prodotti made in Italy nel mondo, non è stata realizzata. Insomma, il Movimento 5 stelle sta raccontando al paese la propria vittoria alle elezioni in modo meno efficace di Salvini.
A distanza di sei mesi e con questa consapevolezza, possiamo anche provare a rispondere a una domanda che prima dell’estate aveva molto diviso i commentatori: ha fatto bene il Pd a non allearsi con i 5 stelle?
Per un breve momento tra il 4 marzo e la formazione del governo Conte, infatti, era sembrata possibile un’intesa Pd-M5S. Il principale promotore di quello che in altri tempi sarebbe stato definito “inciucio” era Roberto Fico, presidente della Camera, oggi membro isolato e insoddisfatto della inesistente sinistra del movimento. L’idea venne affossata proprio dal Pd, dopo un breve dibattito interno. Il più scettico sull’idea dell’alleanza era Matteo Renzi, seguito da tutta la propria corte. Nonostante in quei giorni dichiarasse di non essere il leader del partito, impose di fatto la propria linea al “reggente” Maurizio Martina, più possibilista su un’apertura a Fico.
I renziani erano convinti — e forse lo sono ancora — che gli italiani si sarebbero presto resi conto di aver fatto un errore votando Di Maio e Salvini, e sarebbero presto tornati a implorare il ritorno del salvatore di Firenze. Con il discutibile l’hashtag #toccaaloro consegnò il paese nelle mani di un governo di estrema destra, sostanzialmente per un calcolo politico superficiale misto a ripicca.
La storia di questi sei mesi però ha dimostrato che, se c’è un modo per logorare il Movimento 5 stelle, è metterglisi vicino, dettandogli l’agenda, prendendo posizioni forti che sia costretto a inseguire. Se l’avesse fatto il Pd anziché la Lega si sarebbe evitato un governo di estrema destra — un semplice fatto che chiunque si definisca di simpatie progressiste dovrebbe caldeggiare — e si sarebbe potuto provare a erodere consenso a quello che il 4 marzo era il primo partito italiano.
Perché fosse possibile questo sviluppo, però, era necessaria un’analisi approfondita del Pd, a partire dal motivo stesso della sua esistenza. Ad esempio: di chi vuole fare gli interessi il Pd? Per quale motivo le persone dovrebbero votarlo? Solo dando risposte forti a quesiti come questo si sarebbe potuto avere un motivo per andare al governo che non fosse semplicemente la convinzione di essere più belli e più saggi degli altri, come è stato sbandierato in campagna elettorale, e poter sedersi a un tavolo a discutere con qualcuno su qualche possibile accordo.
Nei primi sei mesi dopo le elezioni, questa analisi è completamente mancata nel catatonico centrosinistra italiano.
Liberi e uguali ha incassato la sconfitta come un colpo mortale, e probabilmente 99 elettori italiani su 100 non sarebbero in grado di dire se oggi la sigla esiste ancora, tra vagabondaggi di Civati e iniziative settembrine di Laura Boldrini. La situazione, se possibile, è ancora peggiore appunto nel Pd, che ha aspettato mesi appeso a Renzi, vegetando nella reggenza di Martina per non affrontare un congresso — in cui magari qualcuno avrebbe avuto qualcosa da ridire sul fatto che Renzi avrebbe dovuto ritirarsi dopo il referendum del 2016 e invece è riuscito nel non facile compito di distruggere i rimasugli di credibilità del partito.
Il massimo dell’indegnità, dell’insensatezza da fine impero, nel Partito democratico lo si è toccato a fine luglio, quando si è deciso di indire una manifestazione antirazzista ma per dopo le vacanze — tra l’altro con i flussi migratori ormai diminuiti rispetto all’estate — perché chi ha voglia di fare una manifestazione ad agosto se anche la gente annega. La manifestazione è stata edulcorata in una più generica contro il governo, e si terrà il 29 settembre.
Qualcosa sembra essersi mosso solo negli ultimi giorni, con il consolidamento della candidatura anti-renziana del governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che ha ottenuto il supporto anche di Dario Franceschini. Sembra certo che il partito terrà un congresso a fine ottobre. Forse, se Zingaretti riuscirà a vincere, potrà essere arrestata la china discendente che il Pd sembra aver imboccato inarrestabilmente nei sondaggi.
Le elezioni europee di fine maggio 2019 saranno un banco di prova molto importante, e aprono il campo a domande che è giusto porsi come “cosa succederebbe se si andasse a votare oggi?” o “cosa succederà nei prossimi sei mesi?”
Proprio ieri è stato reso noto un sondaggio Piepoli secondo cui la Lega avrebbe compiuto il sorpasso sul Movimento 5 Stelle, con un’aspettativa del 30% di voti rispetto al 29% se si tornasse al voto oggi. Il Partito democratico a luglio si attestava tra il 17% e il 18%, mentre ad agosto potrebbe aver subito una flessione fino al 15%. La situazione insomma non è tra le migliori per il centrosinistra, considerata anche la tendenza della destra italiana a raccogliere alle urne più voti di quanto pronosticato in precedenza da qualsiasi sondaggio.
Dare una risposta alla seconda domanda, invece, è più difficile, ma ci si può provare. Innanzitutto, bisogna identificare chi è il principale animatore di questo governo, chi detta di fatto la linea nel dibattito pubblico. La risposta è, ovviamente, Salvini. Poi va capito chi avrebbe più interesse tra i due alleati a tornare alle urne. La risposta è chi sta crescendo nei sondaggi, quindi anche in questo caso Salvini. In sostanza, dunque, questo governo durerà finché a Salvini converrà, ovvero fin quando si sentirà abbastanza forte rispetto al Movimento 5 stelle da poter tornare alle urne e vincere a mani basse, magari governando da solo, con Fratelli d’Italia e i rimasugli di Forza Italia.
Anche in base a come andranno le elezioni europee si capirà meglio il futuro equilibrio di potere nella politica italiana. Sempre che a Salvini non venga in mente che votare lo stesso giorno per le elezioni europee e per quelle politiche potrebbe essere un boost per il suo discorso antieuropeista, che verrà ancora più esacerbato dal prevedibile scontro autunnale tra Roma e Bruxelles sulla Legge di stabilità. La sua narrazione, a sei mesi dal voto, è l’unica forte e chiara. Per questo sta purtroppo riuscendo a infiltrarsi e imporsi nella maggioranza del paese, come un veleno.
Segui Stefano su Twitter
Per ricevere tutte le notizie da The Submarine, metti Mi piace su Facebook, e iscriviti al nostro gruppo.




