Per far pagare le tasse ad Amazon non bastano gli accordi con il fisco
L’evasione è particolarmente lampante in casi come quello di Apple e Amazon, che vendono tantissimi beni fisici.

L’evasione è particolarmente lampante in casi come quello di Apple e Amazon, che vendono tantissimi beni fisici.
La notizia è di oggi: Amazon ha concluso con il fisco italiano un accordo da 100 milioni di euro, per chiudere un contenzioso su un’evasione fiscale da 130 milioni. L’agenzia delle entrate contestava al colosso di Jeff Bezos una “omessa dichiarazione dei redditi” nel periodo compreso tra il 2009 e il 2014, e per questo alcuni manager europei dell’azienda erano stati iscritti nel registro degli indagati dalla procura di Milano a marzo dell’anno scorso. Con l’accordo di oggi, anche il procedimento penale viene a cadere.
La stessa accusa era stata rivolta in precedenza a Apple e Google. Apple aveva evaso 880 milioni di euro, e aveva finito per pagarne soltanto 318 milioni, nel 2015: uno sconto notevole per un’accusa dove sono solitamente previste salate penali. Lo stesso anno anche Google aveva risolto un contenzioso con lo stato, per una cifra simile — 306 milioni. Da allora, perlomeno teoricamente, Google e Amazon versano regolarmente le tasse in Italia.
Anche Facebook ha annunciato, pochi giorni fa, che comincerà a fatturare i ricavi pubblicitari non soltanto in Irlanda — dove gode di condizioni fiscali favorevoli — ma in tutti i paesi in cui effettivamente eroga i propri servizi. I metodi per continuare a pagare di meno, però, non mancano: in primis, abbattere gli utili tassabili spostando denaro da una sussidiaria all’altra (il cosiddetto transfer pricing).
Nelle ultime settimane, in Italia si è parlato molto di “web tax,” una proposta di legge che, salvo sorprese, sarà inclusa nella legge di bilancio, di prossima approvazione. Presentata dal senatore del Pd Mucchetti, la legge prevederebbe l’introduzione di un’imposta del 6 percento sul fatturato delle vendite di servizi digitali da un’azienda all’altra — ma l’elenco completo dei servizi tassabili sarà stilato successivamente da un decreto ministeriale.
Ma la web tax avrebbe proprio lo scopo di accertare la presenza di una “stabile organizzazione” in Italia, e quindi non si applicherà alle aziende che, come Apple, Google e Amazon, hanno già patteggiato con il fisco e si sono impegnate, d’ora in poi, a pagare regolarmente le tasse nel nostro paese. Non è chiaro, invece, se la web tax potrà fare qualcosa per evitare il transfer pricing (probabilmente no.)
L’evasione è particolarmente lampante in casi come quello di Apple e Amazon, che vendono tantissimi beni fisici. Amazon ha grandi stabilimenti di distribuzione in tutto il paese, Apple ha 16 negozi monomarca. La pretesa che si tratti di aziende “fluide,” che non hanno presenza sul territorio statale, è semplicemente ridicola.

Nel frattempo, il Lussemburgo si trova in una situazione piuttosto paradossale: lo scorso ottobre, la Commissione europea ha intimato ad Amazon di rimborsare al Granducato 250 milioni di euro di “indebiti benefici fiscali,” ma il governo del paese, invece di incassare contento, ha annunciato oggi che farà ricorso, respingendo l’accusa di aver offerto un “vantaggio selettivo” all’azienda di Seattle. Una posizione simile era stata assunta dall’Irlanda proprio quest’anno: il paese si era rifiutato di fronte all’Unione Europea di pretendere i 13 miliardi di euro che il colosso di Cupertino avrebbe dovuto in tributi. (Alla fine l’Ue ha avuto la meglio, e, sebbene Apple si stia preparando a fare appello, è probabile che l’azienda finirà per dover pagare l’intera cifra.) (Amici lussemburghesi, accettate i soldi e poi dateli a the Submarine.)
Questo la dice lunga sul potere di ricatto che aziende di questo genere, con fatturati miliardari, possono esercitare nei paesi in cui operano.
L’accordo con il Lussemburgo finito nel mirino dell’Unione europea prevedeva una struttura fiscale iper-complessa — nota internamente come “Progetto Goldcrest,” dal nome dell’uccello nazionale del granducato — e rivelata dal Guardian attraverso i documenti processuali di un contenzioso aperto tra Amazon e l’agenzia delle entrate statunitense (IRS), a febbraio 2016. Attraverso un sistema di holding e società controllate, Amazon era in grado di erodere significativamente il margine dei profitti tassabili, trasferendo da una parte all’altra i propri ricavi.
Due anni prima, lo scandalo LuxLeaks — 28 mila pagine di documenti relativi a più di mille aziende — aveva rivelato come il Lussemburgo sistematicamente concedesse a numerose multinazionali accordi fiscali favorevoli e strutturati ad hoc. Le rivelazioni avevano messo in un certo imbarazzo il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che del Lussemburgo è stato primo ministro dal 1995 al 2013, ma senza ripercussioni politiche di rilievo. Nel frattempo, i due whistleblower e la giornalista che per prima ha rivelato i documenti sono stati condannati in appello da un tribunale lussemburghese quest’anno. A fine novembre è iniziato il processo in terzo grado.
Per l’Europa quello della macro-evasione fiscale non è un problema solo interno: le multinazionali statunitensi sono tenute a pagare le tasse sull’intero proprio capitale, non solo su quanto rimpatriano. Ma c’è una agile via di fuga: se una multinazionale può dimostrare che reinvestirà quelle risorse in operazioni estere, può ritardare a tempo indeterminato il pagamento presso la IRS. Per gli Stati Uniti è un problema gigantesco: secondo un rapporto Oxfam del 14 aprile 2016, gli Stati Uniti sono vittima di 1,4 triliardi di dollari di evasione fiscale. Risorse che aziende come Amazon, Apple, e Google indicano come “sospese” nelle nebbie del sistema tributario europeo, o in attesa di stanziamenti per ulteriori espansioni — nuovi stabilimenti, nuovi Apple Store, nuovi server — ma che sono principalmente accumulate, nella migliore delle ipotesi per poi essere pagate, alla fine, in dividendi o buyback.
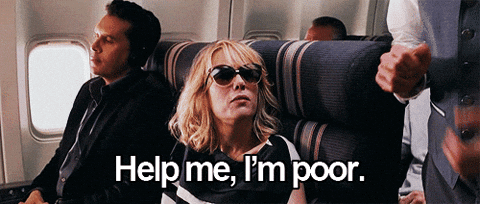
È esaminando la dimensione internazionale che la posizione di Amazon si fa insostenibile: le tasse su questi profitti vanno pagate — e il problema va al di là dell’Italia: l’azienda può sostenere, se ritiene, che il proprio valore sia altrove — e la responsabilità di un’azienda, nei confronti dei propri investitori, è di pagare meno tasse possibile — ma deve pagarle da qualche parte.
Al contrario, Amazon ha per anni cercato di non pagare tasse sulle vendite al cliente neanche in patria, ed è stato costretto a raccogliere i tributi in maniera organica a livello federale solo in tempi recenti, chiudendo i propri ultimi fronti tax free solo lo scorso primo aprile.
Una posizione amichevole nei confronti delle aziende è sostenere che dovrebbero essere i singoli stati a costruire sistemi di incentivi per convincere i privati a versare le tasse che devono — e che la situazione tributaria assurdista dell’Unione Europea è la ragione principale di queste tensioni. Un’analisi più secca? L’esistenza di multinazionali come Amazon e Apple è antitetica al sano funzionamento di uno Stato, e se questi ultimi vogliono fare rispettare le proprie leggi devono farle rispettare, con la forza, senza alternative. Lo dice anche Dio.




