Hamburger politik
Dal salario minimo garantito ai robot, la guerra del mercato del lavoro USA si combatte nei fast food

I fast food — all’apparenza simboli un po’ demodé del consumismo novecentesco, invecchiati insieme ai movimenti no global per lasciare spazio ai nuovi brand del tecno-capitalismo digitale — nelle ultime settimane sono tornati a guadagnare qualche titolo di giornale, per diverse ragioni.

La Salvia è una pianta magica: il suo nome vuol dire salvatrice.
La nuova linea profumata Erbaflor
[button color=”white” size=”normal” alignment=”none” rel=”follow” openin=”samewindow” url=”http://www.erbaflor.com/it/disalvia”]Scopri di più[/button]
Il 29 novembre è morto a 98 anni Michael “Jim” Delligatti, creatore del Big Mac, l’iconico doppio panino di McDonald’s. Delligatti aveva cominciato a vendere la propria creatura nella sua filiale del ristorante a Uniontown, Pennsylvania, nel 1967.

Il 7 dicembre, invece, è uscito nelle sale statunitensi The Founder, un film di John Lee Hancock sulla storia di Ray Kroc, proprietario del marchio dal 1961 e padre di fatto di McDonald’s come lo conosciamo (in Italia uscirà a gennaio). Sul Venerdì di Repubblica di questa settimana c’è un’intervista a Michael Keaton, che nel film interpreta Kroc. L’attore mette subito in chiaro: “non è una storia del fast food, ma una parabola sul capitalismo in America.”
La pellicola, scrive Stefano Pistolini, descrive una “nazione bianca, razzialmente gerarchizzata, placidamente maschilista, instancabilmente dedita alla celebrazione di quel sogno americano che sembrava contenere tutto,” in consonanza con la vecchia-nuova America vagheggiata da Trump e dai suoi sostenitori.
Tempismo perfetto: l’8 dicembre il presidente eletto ha annunciato la nomina a Segretario del Lavoro di Andy Puzder, amministratore delegato di CKE Restaurants Holdings Inc., che comprende le due catene di fast food Carl’s Jr. e Hardee’s — famosa, la prima, per una serie di spot pubblicitari al limite del pornografico e americanissimi ben oltre lo stereotipo, in cui panini farciti senza cura della legge della gravitazione universale vengono trasformati in oggetti erotici nelle mani di super-modelle discinte. Del resto, Puzder non ha fatto mistero della propria passione per le “belle donne in bikini che mangiano hamburger” (una situazione frequente nella vita reale).
Gusti erotico-gastronomici a parte, per quanto riguarda le questioni più strettamente connesse al mercato del lavoro, la nomina di Puzder ha fatto alzare più di un sopracciglio tra gli stessi elettori di Trump, date innanzitutto le sue posizioni esplicitamente pro-immigrazione — di cui non è difficile capire il perché: l’industria dei fast food si regge in gran parte sulla manodopera a basso costo di immigrati, regolari e non.
Basically the Trump administration is a giant prank on Trump voters.
— David Frum (@davidfrum) December 8, 2016
Negli ultimi quattro anni i fast food statunitensi sono stati protagonisti di una serie di scioperi e proteste per il miglioramento delle condizioni di lavoro e l’innalzamento del salario minimo a 15 dollari l’ora. Una battaglia che, appoggiata anche da Bernie Sanders e non esente da scontri piuttosto duri con le forze di polizia, ha finito per coinvolgere anche altre classi di lavoratori a basso reddito — operatori delle pulizie, infermieri, impiegati precari — ed è riuscita a raggiungere qualche conquista importante: a New York il salario minimo è stato innalzato a 10,5 dollari l’ora, con il piano di estenderlo a 15 entro il 2018, e provvedimenti simili sono stati adottati in molte altre città, tra cui Los Angeles e San Francisco, mentre il salario minimo federale al momento resta fermo a 7,25 dollari.
A Seattle, l’incremento annuale del salario minimo — con l’obiettivo di raggiungere i 15 dollari già dall’anno prossimo in alcuni settori — è in vigore da più di un anno e non sembrano essersi verificati i contraccolpi economici paventati dai detrattori della misura: in città, anzi, la disoccupazione è scesa quest’anno al 3,4%, due punti percentuali in meno rispetto al 2014, quando è stata approvata la legge. Il che sembrerebbe dimostrare — non senza il supporto di studi approfonditi— che salari più alti non comportano automaticamente una diminuzione dei posti di lavoro e un danno economico per le imprese.

Cosa ne pensa il nuovo segretario del lavoro, Andy Puzder? Nulla di buono: a ottobre 2014 era in prima fila tra gli oppositori della proposta di Obama di innalzare il salario minimo federale da 7,25 a 10,10 dollari, scrivendo, in un op-ed sul Wall Street Journal, che “se i governi potessero trasformare ruoli non qualificati di livello base in lavori a medio reddito, l’Unione Sovietica sarebbe oggi la prima economia mondiale.” Di fronte all’aumento del costo del lavoro, agli imprenditori non restano che due alternative: alzare i prezzi o tagliare posti, appoggiandosi più pesantemente all’automazione.
Della seconda opzione, Puzder è tornato a parlare più di recente, a marzo scorso, visitando un ristorante della catena di fast food quasi completamente automatizzati Eatsa — niente code, niente cassieri, niente nonsense, come si legge sul sito della startup. In quell’occasione, Puzder ha detto a Business Insider: “[le macchine] sono sempre educate, vendono di più, non vanno mai in vacanza, non arrivano mai in ritardo, non subiscono infortuni, né sollevano casi di discriminazione d’età, sesso o razza.”
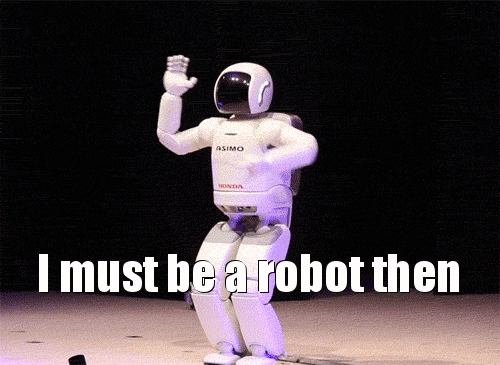
(La strada della lotta per i diritti delle macchine è ancora molto lunga.)
Donald Trump ha fatto della creazione di nuovi posti di lavoro — o meglio, del ritorno in America degli impieghi delocalizzati all’estero — uno dei refrain della propria campagna presidenziale: per questo le dichiarazioni di Puzder sono state ripescate dagli archivi con una certa ironia — ma hanno riportato l’attenzione su un tema cruciale per il prossimo futuro.
I danni che l’automazione potrebbe causare al mercato del lavoro sono oggetto di studio da anni, con conclusioni abbastanza univoche: una ricerca di Oxford, molto citata, nel 2013 stimava che il 47% dei lavori negli Stati Uniti sono a rischio di essere automatizzati entro 20 anni; un report più recente ipotizza l’eliminazione del 6% dei lavori entro il 2021. Anche Stephen Hawking si è unito all’allarme, scrivendo a inizio dicembre che “la crescita dell’intelligenza artificiale, verosimilmente, spingerà questa distruzione del lavoro in profondità nelle classi medie: rimarranno solo i ruoli creativi o di supervisione, che richiedono maggior cura.”
E Puzder non ha torto a individuare proprio nei fast food e nella ristorazione in generale — storicamente bacino di lavoro non specializzato — un luogo privilegiato per la disruption robotica. Non c’è soltanto Eatsa: come nota Recode, già da tempo le macchine si occupano di arrotolare sushi, preparare il ramen o gli hamburger, mentre una startup di Mountain View pensa di farci la pizza (con buona pace della veracità certificata) — il futuro sembra essere nel cibo preparato da robot e consegnato a domicilio da robot, o acquistato in negozi senza cassieri.
Nel 2012, negli Stati Uniti risultavano impiegati 3,3 milioni di cassieri, a cui vanno aggiunti quasi 3 milioni di impiegati nella ristorazione, fast food inclusi: numeri che fanno capire come queste innovazioni tecnologiche potrebbero avere effetti sociali potenzialmente disastrosi. Ma non è inevitabile che l’automazione provochi una perdita netta di posti di lavoro: come osserva Christopher Mims sul Wall Street Journal, in alcuni casi può verificarsi il contrario — è stato il caso, per esempio, della diffusione dei bancomat.
Non solo: la distruzione di posti di lavoro a basso reddito e scarsamente specializzati, spesso precari e privi di adeguata rappresentanza sindacale, potrebbe, in fondo, non essere un male. È questa l’opinione di alcuni commentatori di sinistra — come Peter Frase di Jacobin — che auspicano che la diminuzione di posti di lavoro provocata dall’automazione possa portare a una migliore distribuzione del lavoro e della ricchezza esistenti: salari minimi più alti, orari ridotti, reddito di base universale.
Il punto, così, ritorna dalla tecnica alla politica: “L’automazione non è una parte neutrale e inevitabile del capitalismo,” scriveva a inizio anno lo staff del magazine N+1. “Emerge attraverso il desiderio di rompere i sistemi formali e informali di controllo nelle mani dei lavoratori — inclusi i sindacati — per rimpiazzarli con sistemi a cottimo controllati managerialmente e minuziosamente sorvegliati.”
E non solo l’automazione, ma anche i suoi effetti dipenderanno in ultima analisi da precise scelte di politica economica — almeno finché le intelligenze artificiali non riusciranno a occupare anche i ministeri del lavoro. A Andy Puzder questo potrebbe non piacere.




